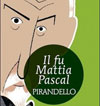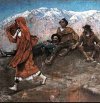Antefatto
Clorinda, eroina pagana, uscita notte-tempo da Gerusalemme con Argante per incendiare e distruggere la torre mobile di legno che i cristiani avevano costruito per colpire dall’alto le mura della città, compiuta l’audace impresa, è rimasta chiusa fuori dalla Aurea porta di Gerusalemme, subito richiusa da Argante e dai suoi, perché si è attardata per uccidere un guerriero cristiano che l’aveva colpita, Arimone.
TESTO
PARAFRASI
[49]
Sola esclusa ne fu perché in quell'ora
ch'altri serrò le porte ella si mosse,
e corse ardente e incrudelita fora
a punir Arimon che la percosse.
Punillo; e 'l fero Argante avisto ancora
non s'era ch'ella sí trascorsa fosse,
ché la pugna e la calca e l'aer denso
a i cor togliea la cura, a gli occhi il senso.
[49]
Resta fuori sola (Sola esclusa ne fu – il soggetto è Clorinda) perché nel momento in cui (in quell'ora) la porta [di Gerusalemme] si chiudeva lei si mosse e corse fuori, piena d’ira e inferocita (ardente e incrudelita), per punire Arimone [un guerriero cristiano] che l'aveva colpita (la percosse). Lo punì (Punillo); e il coraggioso Argante non si era ancora accorto (avisto ancora non s'era) che lei si fosse allontanata tanto (sí trascorsa), poiché la battaglia (pugna), la calca [dei soldati] e l'aria oscura [per il buio della notte e il fumo dell'incendio] toglievano agli animi (cor) e agli occhi ogni sensibilità (senso).
[50]
Ma poi che intepidí la mente irata
nel sangue del nemico e in sé rivenne,
vide chiuse le porte e intorniata
sé da' nemici, e morta allor si tenne.
Pur veggendo ch'alcuno in lei non guata,
nov'arte di salvarsi le sovenne.
Di lor gente s'infinge, e fra gli ignoti
cheta s'avolge; e non è chi la noti.
[50]
Ma dopo che [Clorinda] ebbe placato il proprio animo sfogando l’ira (intepidí la mente irata) nel sangue del nemico e tornò in sé (in sé rivenne), vide la porta chiusa e se stessa circondata (intorniata) da nemici, e si ritenne destinata a morire (morta allor si tenne). Tuttavia vedendo che nessuno bada a lei (ch'alcuno in lei non guata), pensa (le sovenne) ad un nuovo modo (nov'arte) di salvarsi. Si finge (s'infinge) una di loro (di lor gente) e si mescola (s'avolge) silenziosa (cheta) tra quei guerrieri sconosciuti (gli ignoti – i cristiani); e nessuno la nota (e non è chi la noti).
[51]
Poi, come lupo tacito s'imbosca
dopo occulto misfatto, e si desvia,
da la confusion, da l'aura fosca
favorita e nascosa, ella se 'n gía.
Solo Tancredi avien che lei conosca;
egli quivi è sorgiunto alquanto pria;
vi giunse allor ch'essa Arimon uccise:
vide e segnolla, e dietro a lei si mise.
[51]
Poi, come un lupo silenzioso (come lupo tacito - similitudine) entra nel bosco (s'imbosca) dopo aver compiuto un misfatto nell'oscurità, e si allontana dalle vie battute (si desvia), così lei se ne andava (ella se 'n gía), favorita e nascosta dalla confusione e dal buio (aura fosca). Capita (avien) che il solo Tancredi la riconosca (lei conosca); egli è sopraggiunto (sorgiunto) qui poco prima, quando lei ha ucciso Arimone: l'ha vista e l'ha tenuta d'occhio (segnolla), iniziando a seguirla.
[52]
Vuol ne l'armi provarla: un uom la stima
degno a cui sua virtú si paragone.
Va girando colei l'alpestre cima
verso altra porta, ove d'entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avien che d'armi suone,
ch'ella si volge e grida: “O tu, che porte,
che corri sí?” Risponde: “E guerra e morte.”
[52]
Vuole (Vuol il soggetto è Tancredi) battersi con lei (ne l'armi provarla): [in quanto] pensa (la stima) che sia un uomo con cui possa degnamente misurare il proprio valore (degno a cui sua virtú si paragone). Lei sta girando intorno alla collina montuosa (alpestre cima - il colle di Sion, dove sorge Gerusalemme) verso un'altra porta in cui poter entrare. Lui la insegue (segue) con impeto, per cui, molto prima di raggiungerla, succede (avien) che le sue armi risuonano (suone) in tal modo (in guisa) che lei si volta e grida: “Tu, che corri in tal modo, cosa porti?” Lui risponde: “Guerra e morte”.
[53]
“Guerra e morte avrai” disse “io non rifiuto
darlati, se la cerchi” e ferma attende.
Non vuol Tancredi, che pedon veduto
ha il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l'uno e l'altro il ferro acuto,
ed aguzza l'orgoglio e l'ire accende;
e vansi a ritrovar non altrimenti
che duo tori gelosi e d'ira ardenti.
[53]
Lei disse: “Avrai guerra e morte, non rifiuto di dartela (darlati) se la cerchi”, e attende ferma. Tancredi, che ha visto il suo nemico a piedi (pedon – senza cavallo), non vuole usare il cavallo e smonta. Ognuno impugna la spada (il ferro - metonimia) acuminata (acuto) e stimola l'orgoglio, infiamma l'ira (aguzza l'orgoglio e l'ire accende - chiasmo); e si scontrano (vansi a ritrovar) in modo simile a due tori, gelosi e ardenti d'ira (duo tori gelosi e d'ira ardenti – metafora).
[54]
Degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno
teatro, opre sarian sí memorande.
Notte, che nel profondo oscuro seno
chiudesti e ne l'oblio fatto sí grande,
piacciati ch'io ne 'l tragga e 'n bel sereno
a le future età lo spieghi e mande.
Viva la fama loro; e tra lor gloria
splenda del fosco tuo l'alta memoria.
[54]
Imprese (opre) così memorabili (sí memorande) meriterebbero (degne) di svolgersi alla luce del sole (d'un chiaro sol), in un teatro pieno [di gente] (d'un pieno teatro). O notte (invocazione alla notte), che hai richiuso nel tuo seno profondo e oscuro e nella dimenticanza (oblio) un’impresa (fatto) così grande, consenti che io te la sottragga (piacciati ch'io ne 'l tragga – intervento diretto del poeta nella vicenda) e la spieghi e la tramandi (mande) nello splendore luminoso ('n bel sereno) [della poesia] alle epoche future (a le future età). Possa la loro fama vivere, e insieme con la loro gloria risplenda anche il ricordo (l'alta memoria) delle tue tenebre (del fosco tuo).
[55]
Non schivar, non parar, non ritirarsi
voglion costor, né qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
toglie l'ombra e 'l furor l'uso de l'arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro, il piè d'orma non parte;
sempre è il piè fermo e la man sempre 'n moto,
né scende taglio in van, né punta a vòto.
[55]
Costoro non vogliono (voglion costor – Clorinda e Tancredi) schivare i colpi, né pararli, né ritrarsi, né in questo duello (qui) la destrezza ha una parte. Non danno i colpi finti, pieni, scarsi (finti, pieni, scarsi – termini tecnici dell’arte del duello): il buio [della notte] (l'ombra) e il furore [dei duellanti] non permette (toglie) di usare (l'uso) la tecnica (arte – arte del duello). Si sentono le spade urtarsi in modo orribile al centro della lama (a mezzo il ferro - metonimia), e il piede non si muove da dove ha lasciato l’orma (il piè d'orma non parte – non indietreggia di un passo); il piede è sempre fermo e la mano è sempre in movimento, e nessun colpo di taglio e nessun colpo di punta scende invano (in van) e a vuoto (a vòto).
[56]
L'onta irrita lo sdegno a la vendetta,
e la vendetta poi l'onta rinova;
onde sempre al ferir, sempre a la fretta
stimol novo s'aggiunge e cagion nova.
D'or in or piú si mesce e piú ristretta
si fa la pugna, e spada oprar non giova:
dansi co' pomi, e infelloniti e crudi
cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.
[56]
La vergogna [per un colpo ricevuto] (L'onta) acuisce (irrita) lo sdegno per vendicarsi (a la vendetta) e la vendetta rinnova poi la vergogna; per cui al ferire e alla furia (fretta) si aggiungono sempre nuovi stimoli e nuove cause (cagion nova). Lo scontro (la pugna - latinismo) si fa di momento in momento (d'or in or) più confuso (piú si mesce) e più serrato (piú ristretta) e non serve più adoperare (oprar) la spada: si colpiscono con le impugnature (dansi co' pomi), e inferociti e crudeli (infelloniti e crudi – la lotta li rende dimentichi di ogni norma di cavalleria) cozzano insieme con gli elmi e gli scudi.
[57]
Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, ed altrettante
da que' nodi tenaci ella si scinge,
nodi di fer nemico e non d'amante.
Tornano al ferro, e l'uno e l'altro il tinge
con molte piaghe; e stanco ed anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.
[57]
Il cavaliere stringe per tre volte [a sé] la donna con le braccia robuste, ed altrettante volte lei si scioglie (si scinge) da quelle strette vigorose (da que' nodi tenaci), che sono proprie di un nemico e non di un amante (nodi di fer nemico e non d'amante - antitesi). Tornano a combattere con le spade (tornano al ferro) ed entrambi le bagnano (tinge) [col sangue] di molte ferite (molte piaghe); e alla fine entrambi indietreggiano (si ritira) stanchi e stremati, e ansimano (respira) dopo una lunga fatica.
[58]
L'un l'altro guarda, e del suo corpo essangue
su 'l pomo de la spada appoggia il peso.
Già de l'ultima stella il raggio langue
al primo albor ch'è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico, e sé non tanto offeso.
Ne gode e superbisce. Oh nostra folle
mente ch'ogn'aura di fortuna estolle!
[58]
Si guardano a vicenda e ognuno appoggia il peso del suo corpo sfinito (essangue) sull'elsa della spada. Ormai impallidisce (langue – si spegne) la luce (il raggio) dell'ultima stella [Venere], al primo albeggiare che appare a oriente (ch'è in oriente acceso). Tancredi vede che il sangue versato dal suo nemico è più abbondante (in maggior copia), mentre lui non è ferito (offeso) in modo altrettanto grave. Ne gode e ne insuperbisce. Oh quanto è folle la nostra mente, che ogni soffio di vento (aura) favorevole (di fortuna) esalta (estolle)!
[59]
Misero, di che godi? oh quanto mesti
fiano i trionfi ed infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Cosí tacendo e rimirando, questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse,
perché il suo nome a lui l'altro scoprisse:
[59]
Misero, di cosa ti rallegri (godi)? Oh, quanto saranno (fiano) tristi i tuoi trionfi (mesti/… trionfi - chiasmo) e quanto infelice il tuo vanto! I tuoi occhi pagheranno (sempre che sopravvivi) con un mare di pianto (mar di pianto - iperbole) ogni goccia di quel sangue (di quel sangue ogni stilla - anastrofe). Così, tacendo e osservandosi (rimirando), questi guerrieri insanguinati smisero di combattere (cessaro) per qualche tempo. Alla fine Tancredi ruppe il silenzio e disse, per far sì che l'altro rivelasse (scoprisse) il suo nome:
[60]
“Nostra sventura è ben che qui s'impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte rea vien che ci neghi
e lode e testimon degno de l'opra,
pregoti (se fra l'arme han loco i preghi)
che 'l tuo nome e 'l tuo stato a me tu scopra,
acciò ch'io sappia, o vinto o vincitore,
chi la mia morte o la vittoria onore.”
[60]
“Per noi è davvero una sfortuna che ci battiamo tanto valorosamente (s'impieghi tanto valor) qui, dove è coperto dal silenzio. Ma poiché avviene (vien) che una sorte crudele (rea) ci nega sia il plauso (lode) sia testimoni degni della nostra impresa (de l'opra – si riferisce al duello), io ti prego (se in una battaglia le preghiere hanno spazio) di rivelarmi (a me tu scopra) il tuo nome e la tua condizione ('l tuo stato), affinché io sappia, vinto o vincitore, chi renda onorata la mia morte o la mia vittoria”.
[61]
Risponde la feroce: “Indarno chiedi
quel c'ho per uso di non far palese.
Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese.”
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi,
e: “In mal punto il dicesti;” indi riprese
“il tuo dir e 'l tacer di par m'alletta,
barbaro discortese, a la vendetta.”
[61]
La feroce [guerriera] risponde (Risponde la feroce - apostrofe): “Inutilmente (Indarno) mi chiedi quello che per abitudine (per uso) non rivelo. Ma chiunque io sia, tu vedi di fronte a te uno dei due che ha incendiato la grande torre”. Tancredi a quelle parole arse di sdegno e riprese: “L'hai detto nel momento sbagliato;” e poi riprese “quel che dici (il tuo dir) e ciò che taci ('l tacer), o barbaro scortese, mi incitano in ugual modo (di par) alla vendetta”.
[62]
Torna l'ira ne' cori, e li trasporta,
benché debili in guerra. Oh fera pugna,
u' l'arte in bando, u' già la forza è morta,
ove, in vece, d'entrambi il furor pugna!
Oh che sanguigna e spaziosa porta
fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna,
ne l'arme e ne le carni! e se la vita
non esce, sdegno tienla al petto unita.
[62]
Nei loro cuori torna l'ira e li trasporta, anche se deboli, allo scontro. Oh che battaglia furibonda, dove (u' – sta per ubi, dove in latino) ogni arte [schermistica] è messa da parte (in bando), dove anche il vigore (la forza) non c’è più (è morta), e dove, invece, combatte (pugna) il furore di entrambi! Oh quale ferita (porta) sanguinante e profonda provoca (fa) l'una e l'altra spada, ovunque colpisca (giugna), nell'armatura e nelle carni! E se la vita non ne esce ancora, è lo sdegno che la tiene (tienla) unita al corpo (al petto).
[63]
Qual l'alto Egeo, perché Aquilone o Noto
cessi, che tutto prima il volse e scosse,
non s'accheta ei però, ma 'l suono e 'l moto
ritien de l'onde anco agitate e grosse,
tal, se ben manca in lor co 'l sangue vòto
quel vigor che le braccia a i colpi mosse,
serbano ancor l'impeto primo, e vanno
da quel sospinti a giunger danno a danno.
[63]
Come il profondo (l'alto) [mar] Egeo, sebbene (perché) abbiano smesso di soffiare (cessi) l'Aquilone (vento del nord) o il Noto (vento del sud), che prima tutto lo sconvolsero (il volse) e agitarono (scosse), non si placa subito (non s'accheta ei però), ma conserva (ritien) ancora il suono e il moto delle onde grosse e agitate, così (tal), anche se manca in loro (in lor - ai due guerrieri) per il sangue versato (co 'l sangue vòto) quel vigore che mosse le braccia ai primi colpi, [essi] conservano (serbano) ancora l’ impeto iniziale (l'impeto primo) e, spinti da quello (da quel sospinti), vanno ad aggiungere danno a danno. [Similitudine]
Vedi anche le ottave seguenti:
La morte di clorinda - parafrasi e analisi Ottave 64-69 - Gerusalemme liberata -
Riassunto
Clorinda non riuscendo a rientrare a Gerusalemme cerca, per salvarsi, di confondersi tra i nemici, approfittando dell’oscurità.
Tancredi ha notato questo guerriero sconosciuto e ne spia le mosse, non immaginando che possa trattarsi di Clotilde, la donna di cui è perdutamente innamorato. Clorinda che indossa una armatura scura, e non la sua solita armatura argentea e luccicante, cerca di defilarsi tentando di raggiungere l’altra porta di Gerusalemme ma Tancredi segue tutti i suoi spostamenti ed infine la sfida a duello.
Il combattimento tra i due si compie senza testimoni nel cuore della notte, è un duello lungo, furioso e sfibrante che diventa ad un certo punto un corpo a corpo di incredibile violenza. Tancredi ignora fino all’ultimo che il guerriero che incalza con tanto impeto è la donna amata e che ha sognato spesso di stringere tra le braccia.
Il combattimento continua feroce per tutta la notte fino a che, sfiniti, i due contendenti si concedono una pausa e Tancredi domanda all’avversario il suo nome, ma Clorinda fino all’ultimo rifiuta di farsi riconoscere e si limita a rispondere orgogliosamente che è uno di quei guerrieri che hanno incendiato la torre. La risposta di Clorinda è provocatoria e Tancredi sentendola riprende con ancora maggiore ira e accanimento il duello.
Analisi
Fin dal primo canto l’amore di Tancredi per Clorinda corre parallelo alle vicende della guerra ed in questo XII canto giunge al suo infausto epilogo.
Tasso canta in questo brano il triste destino dei protagonisti, condannati in quanto uomini a vivere in un mondo ingannevole e caduco, in cui le uniche realtà certe sono la solitudine e la morte.
Il poeta avverte l’inquietudine per gli aspetti contradditori della vita ed il contrasto tra apparenza e realtà, tra incognito e conosciuto è alla base di tutto l’episodio.
La scena in cui Tancredi abbraccia in più riprese il proprio avversario per colpirlo e fargli del male, non sapendo che chi stringe è colei che ama e anela, è una dimostrazione dell’assurdità del destino che, secondo la concezione esistenziale di Tasso, si fa beffe degli uomini e dei loro desideri. Così il punto in cui Tancredi si rallegra nel vedere che il suo nemico è più malconcio di lui denuncia la tristezza della condizione umana che vede spesso l’uomo rallegrarsi per qualcosa che è destinato a risolversi in una terribile delusione (come sarà per Tancredi scoprire chi si cela nell’avversario). Tasso vuole dunque dimostrare quanto l’uomo non sia artefice del proprio destino condizionato ed ingannato com’è dall’aspetto esteriore e dalle apparenze.
La particolarità dell’episodio narrato in questo brano è data dalla presenza costante del poeta che rivela una profonda partecipazione emotiva e interviene a volte direttamente, vedi ottave 54,1-8; 58,7 e 59,1-4.
Nel 1638 l’episodio del combattimento di Clorinda e Tancredi venne musicato da Monteverdi.
Le fasi del duello
L’episodio del duello risulta diviso in due tempi:
- La zuffa notturna che arriva al corpo a corpo tra i due guerrieri;
- Il duello mortale quando sorge il sole e la luce mette in rilievo il rosso delle ferite. Tancredi vede che il sangue del suo nemico è sparso in maggior copia del suo e se ne rallegra. La luce del sole nascente prepara il fatale riconoscimento di Clorinda da parte di Tancredi.
Clorinda guerriera
La figura della donna bella e guerriera, della amazzone coraggiosa, capace di combattere al pari e meglio dell’uomo, quale è Clorinda, ha dei precedenti nella tradizione epica, ne sono un esempio:
- Camilla nell’Eneide;
- Bradamante nell’Orlando Furioso.
Per tutta la parte del canto relativa al duello il personaggio di Clorinda incarna il guerriero che si attiene in tutto e per tutto a comportamenti e atteggiamenti basati sul codice epico.
Metrica e stile
Ottave con schema: ABABABCC.
Lo stile è mosso, elevato e solenne volto a rendere il pathos lirico-elegiaco della situazione. Il ritmo della sintassi si adegua al ritmo serrato e alterno dello scontro in una progressione ritmica sempre più concitata.
La forte tensione drammatica è espressa anche attraverso l’utilizzo di numerose figure retoriche, in particolare antitesi e opposizioni segnano l’intero brano, visibili anche nel lessico ambiguo che pur essendo riferito ad un duello ricorda l’amore.
Oltre a quelle individuate nella parafrasi vi sono anche:
- Paradosso all’ottava 54 “splenda del fosco tuo”, espressione in apparenza assurda.
- Anadiplosi:
- ottave 52 e 53 “E guerra e morte/guerra e morte avrai”
- ottava 56 “L'onta irrita lo sdegno a la vendetta,/e la vendetta poi l'onta rinova;” (anche chiasmo)
- Paronomasia all’ottava 49 “a punir…/Punillo”
- Significativo tra i tanti enjambement all’ottava 58 “Oh nostra folle/mente ch'ogn'aura di fortuna estolle!” spezza la frase separando l’aggettivo folle e il sostantivo mente inducendo la riflessione sul concetto espresso.
- Chiasmo:
- ottava 53 “aguzza l'orgoglio e l'ire accende” – verbo- sostantivo/sostantivo-verbo – al centro i sostantivo e alle estremità i verbi – suggerisce visivamente l’idea dello scontro imminente
- ottava 56 “L'onta irrita lo sdegno a la vendetta,/e la vendetta poi l'onta rinova;” (anche anadiplosi).