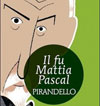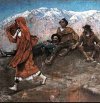Antefatto
Rinaldo si trova nella più alta e solitaria delle isole Fortunate (probabilmente le attuali isole Canarie), dove è stato trasportato dalla maga Armida che lì ha il suo palazzo. Egli, prigioniero del fascino della maga è dimentico di sé e dei suoi doveri e trascorre il suo tempo in ozio nel giardino che circonda il palazzo, tra le braccia della maga che si è perdutamente innamorata di lui.
Goffredo di Buglione ha incaricato di ritrovarlo e riportarlo al campo, i crociati Ubaldo e Carlo, i quali su indicazioni del mago di Ascalona, hanno varcato l’oceano Atlantico per raggiungerlo.
In base alle indicazioni del mago (XIV, 76, 5-8) superano vari ostacoli e giungono infine nel giardino di Armida.
TESTO
PARAFRASI
[9] Poi che lasciar gli aviluppati calli,
in lieto aspetto il bel giardin s’aperse:
acque stagnanti, mobili cristalli,
fior vari e varie piante, erbe diverse,
apriche collinette, ombrose valli,
selve e spelonche in una vista offerse;
e quel che ’l bello e ’l caro accresce a l’opre,
l’arte, che tutto fa, nulla si scopre.
[9] Dopo che [Carlo e Ubaldo] lasciarono i sentieri intricati (aviluppati calli – sono quelli del labirinto che circonda il giardino), si aprì [alla loro vista] il bel giardino dall’aspetto ridente: mostrò a un solo sguardo (in una vista offerse) laghi (acque stagnanti), ruscelli (mobili cristalli - metafora), svariati fiori e piante, erbe diverse, soleggiate (apriche) collinette, valli ombrose, selve e grotte (spelonche); e, quel che accresce la bellezza e il pregio (’l caro) di quelle opere (a l’opre), è che non è visibile l'arte [magica] che ha creato tutto questo (che tutto fa).
[10] Stimi (sì misto il culto è co ’l negletto)
sol naturali e gli ornamenti e i siti.
Di natura arte par, che per diletto
l’imitatrice sua scherzando imiti.
L’aura, non ch’altro, è de la maga effetto,
l’aura che rende gli alberi fioriti:
co’ fiori eterni eterno il frutto dura,
e mentre spunta l’un, l’altro matura.
[10] Ritieni, così bene armonizzato (sì misto) è l’artificioso (il culto) con ciò che è lasciato allo stato di natura (co ’l negletto), che sia (e… e - polisindeto) i luoghi (i siti) sia gli ornamenti siano del tutto (sol) naturali.
Sembra un artificio della natura (Di natura arte par), che per divertimento imiti scherzando la sua imitatrice [ossia l'arte stessa]. La brezza (aura) è come tutto il resto (non ch’altro) un artificio (effetto) della maga, aria (aura - anafora) che fa fiorire gli alberi: con i fiori eterni il frutto dura [in eterno], e mentre un frutto spunta l'altro già matura.
[11] Nel tronco istesso e tra l’istessa foglia
sovra il nascente fico invecchia il fico;
pendono a un ramo, un con dorata spoglia,
l’altro con verde, il novo e ‘l pomo antico;
lussureggiante serpe alto e germoglia
la torta vite ov’è piú l’orto aprico:
qui l’uva ha in fiori acerba, e qui d’or l’have
e di piropo e già di nèttar grave.
[11] Sullo stesso albero (tronco) e tra le stesse foglie, accanto al fico appena nato (nascente) invecchia [un altro] fico; il frutto già maturo (pomo antico) e quello nuovo pendono da un ramo, uno con la buccia (spoglia) dorata e l'altro verde; la vite ritorta (torta vite) serpeggia verso l’alto rigogliosa (lussureggiante serpe alto) e germoglia dove il giardino (orto) è più assolato (aprico): qui l'uva è ancor in fiore, acerba, e qui ha (have – sta per ha - epitesi) il colore dell’oro e del piropo (piropo è una pietra di colore rosso) e già piena di succo (di nèttar grave).
[12] Vezzosi augelli infra le verdi fronde
temprano a prova lascivette note;
mormora l’aura, e fa le foglie e l’onde
garrir che variamente ella percote.
Quando taccion gli augelli alto risponde,
quando cantan gli augei piú lieve scote;
sia caso od arte, or accompagna, ed ora
alterna i versi lor la musica òra.
[12] Uccelli graziosi tra le fronde verdi modulano (temprano) [facendo] a gara (a prova) delle note seducenti (lascivette); la brezza mormora e fa risuonare (garrir) le foglie e le acque che percuote in vario modo (variamente). Quando gli uccelli tacciono [il vento] risponde con un suono più forte (alto), mentre quando gli uccelli cantano più lievemente percuote (scote) [le foglie e l’onda]; o per caso o per arte (sia caso od arte), la brezza musicale (la musica òra) ora accompagna, ed ora si alterna al canto degli uccelli (versi lor).
[13] Vola fra gli altri un che le piume ha sparte
di color vari ed ha purpureo il rostro,
e lingua snoda in guisa larga, e parte
la voce sí ch’assembra il sermon nostro.
Questi ivi allor continovò con arte
tanta il parlar che fu mirabil mostro.
Tacquero gli altri ad ascoltarlo intenti,
e fermaro i susurri in aria i venti.
[13] Fra gli altri [uccelli] ne vola uno che ha le piume variegate (sparte) di colori diversi ed il becco (rostro) rosso (purpureo) e articola (snoda) la lingua in modo ampio (in guisa larga) e divide (parte) la voce in modo da imitare (sí ch’assembra) il nostro linguaggio (sermon nostro). Questo uccello (Questi) allora in quel luogo (ivi) continuò (continovò - arcaismo) con tanta abilità (con arte tanta) il parlare che fu un prodigio meraviglioso (mirabil mostro). Gli altri uccelli tacquero intenti ad ascoltarlo e nell'aria i venti fermarono i loro mormorii.
[14] “Deh mira” egli cantò “spuntar la rosa
dal verde suo modesta e verginella,
che mezzo aperta ancora e mezzo ascosa,
quanto si mostra men, tanto è piú bella.
Ecco poi nudo il sen già baldanzosa
dispiega; ecco poi langue e non par quella,
quella non par che desiata inanti
fu da mille donzelle e mille amanti.
[14] “Oh guarda” cantò “sbocciare (spuntar) la rosa dal suo stelo (dal verde suo) modesta e pura, che è per metà aperta e per metà chiusa (ascosa) e, quanto meno si mostra, tanto più è bella. Ecco poi che già spavalda (baldanzosa) distende (dispiega) i suoi petali (nudo il sen – il grembo aperto); ecco che poi appassisce (langue) e non sembra più la stessa (quella), non sembra quella che prima (inanti) fu desiderata da mille fanciulle e mille amanti.
[15] Cosí trapassa al trapassar d’un giorno
de la vita mortale il fiore e ‘l verde;
né perché faccia indietro april ritorno,
si rinfiora ella mai, né si rinverde.
Cogliam la rosa in su ‘l mattino adorno
di questo dí, che tosto il seren perde;
cogliam d’amor la rosa: amiamo or quando
esser si puote riamato amando.”
[15] Così finisce (trapassa) con il finir del giorno il fiore e la giovinezza (‘l verde) della vita mortale; e per quanto (né perché) la primavera (april) ritorni (faccia indietro…ritorno), ella [la rosa] non rifiorisce (rinfiora) più, né torna verde.
Cogliamo la rosa nel bel mattino (mattino adorno) di questo giorno, che presto (tosto) perde la sua luminosità (il seren perde); cogliamo la rosa d'amore: amiamo adesso (or) quando si può (si puote) essere riamati (riamato amando)”.
Riassunto
Carlo e Ubaldo arrivano nel giardino incantato di Armida dove fiori e frutti sembrano eterni ed è come se la natura si fosse divertita a imitare l’arte e non, come normalmente avviene, il contrario.
Nel giardino è come se non ci fosse l’alternarsi delle stagioni, è un’eterna primavera in cui i frutti maturi pendono dallo stesso albero su cui pendono i frutti acerbi. Tra gli uccelli che cantano spicca un pappagallo prodigioso (mirabil mostro) che imita il linguaggio umano.
Il pappagallo mostra ai due crociati una rosa che sta sbocciando e li invita a coglierla prima che appassisca, affermando che, anche se la primavera tornerà sicuramente, la rosa non fiorirà più, così come avviene per la giovinezza che una volta sfiorita non tornerà.
Analisi del testo
In queste ottave Tasso affida al narratore onnisciente la descrizione dello splendido e lussureggiante giardino di Armida, locus amoenus, attraverso il gusto dei particolari ed immagini suggestive ed evocative. Il giardino rappresenta il paradiso pagano dei piaceri carnali, è frutto della magia di Armida, ma sembra opera della natura, il che accresce il fascino e l’incanto del luogo.
Il pappagallo invita i due crociati ad abbandonarsi alle lusinghe dell’amore, rappresentato dalla rosa appena sbocciata, metafora di una bella fanciulla pronta ad accoglierli.
L’immagine della rosa che subito sfiorisce viene paragonata a quella della giovinezza che presto declina. L’ammonimento è che: bisogna amare quando si può essere riamati, cioè fino a quando c’è la giovinezza, perché la vita è breve e non ritorna dopo la morte.
Armida
Armida è un’invenzione poetica di Tasso, è una figura di fantasia, nipote del re di Damasco. Questa avvenente maga pagana, grande seduttrice, viene inviata da Plutone tra i cristiani per distoglierli dalla loro impresa. Ella vede Rinaldo nell’isoletta di Oronte, addormentato per il magico canto della sirena, e se ne innamora, diventando da nemica ad amante. Si rifugia con lui nell’isoletta incantata della Fortuna.
Armida in questo episodio ricorda la ninfa Calipso dell’Odissea e come lei tiene prigioniero l’uomo di cui è innamorata in un luogo di delizie e piacevolezze. Ma, nello svolgersi della vicenda, si riscontrano anche rimandi alla figura di Didone (Eneide) in quanto emerge di lei non solo il suo profilo di seduttrice ma anche di donna innamorata e abbandonata.
Il giardino
Il giardino rappresenta il locus amoenus, topos letterario ricorrente della cultura classica. Gli spazi sono fatti di colline, valli, selve e spelonche, densi di vegetazione, fauna ed elementi naturali. Brezze, ruscelli, alberi sempre fioriti, frutti che maturano in continuazione, foglie, onde, vari tipi di uccelli, che cantano piacevoli melodie, tra cui il pappagallo; tutto trasmette l’idea dell’abbondanza e sensazioni visive, acustiche e tattili, di forte intensità, ampliate attraverso l’uso di allitterazioni e ripetizioni.
Ma il giardino narrato da Tasso non è un semplice giardino-paesaggio, ma è un giardino incantato in cui aleggia un’atmosfera stregata che ha emulato, superandola, la natura e lo ha reso un giardino-amoroso, luogo di delizie, paradiso pagano.
L’autore vuole trasmettere la visione di un mondo artificioso e seducente, di piaceri e di abbandono ai godimenti terreni, riflesso della sua artefice, il personaggio della maga Armida.
La descrizione del giardino richiama alcuni modelli letterari, tra cui, per esempio, il giardino di Alcinoo (Odissea, libro VII) e del Paradiso dell’Orlando Furioso (VI, 20-22 e XXXIV, 49-53) ed anche l’esempio concreto del parco reale di Torino, primo esemplare europeo di giardino “naturale”, che Tasso visitò durante un viaggio in Piemonte nel 1578.
Il pappagallo
L’esotico e colorato pappagallo non è scelto a caso ma voluto proprio perché in grado di imitare la voce umana, così come Armida è in grado di imitare la natura creata da Dio.
Il pappagallo è umanizzato, è una stramba imitazione dell’uomo, a cui, ironicamente, Tasso fa pronunciare parole da cui emerge il senso della precarietà della vita, della giovinezza e del piacere, un’elegia sulla fugacità della vita, raffigurata dalla rosa che “trapassa al trapassar d’un giorno” (v. 1, ottava 15).
La rosa
La rosa è simbolo della perfezione della natura ed emblema della fugacità della bellezza, della giovinezza e del piacere. Il canto vuole rappresentarne la breve parabola. Anche la rosa viene umanizzata e rievoca il topos catulliano della vergine rosa, fiore bellissimo, simbolo dell’eros femminile e della purezza della donna, ma effimero perché minato dalla caducità.
Analisi metrica
Il passo è composto da ottave in endecasillabi con schema: ABABABCC.
Lo stile è elevato e classicheggiante.
Rime equivoche: ora / òra, vv.7-8 ott.12;
Rime derivative: sparte / parte, vv.1-3 ott.13.
Per rendere l’impressione di piacevolezza ed incanto il poeta utilizza numerose figure retoriche di forte effetto musicale attraverso parallelismi, ripetizioni e accumulazioni.
Figure retoriche
Approfondimento di alcune figure retoriche:
Allitterazioni
- lussureggiante serpe, v.5 ott.11 – allitterazione in s per rappresentare il procedere sinuoso della vite;
- infra le verdi fronde, v.1 ott.12;
- cogliam d’amor la rosa: amiamo or quando / esser si puote riamato amando, vv.7-8 dell’ottava n.15 – l’allitterazione in am introduce e trasmette con intensità crescente la tematica dell’abbandono amoroso.
- non par quella, / quella non par, vv.6-7 ott.14
- l’aura… / l’aura, vv.5-6 ott.10;
- quando… / quando, vv.5-6 ott.12;
- cogliam la rosa …/cogliam … la rosa, vv. 5-7 ott.15;
- acque stagnanti - mobili cristalli, v.3 ott.9;
- apriche collinette – ombrose valli, v.5 ott.9;
- acque stagnanti, mobili cristalli, v.3 ott.9 – sostantivo + aggettivo – aggettivo + sostantivo;
- fior vari e varie piante, v.4 ott.9;
- fiori eterni eterno il frutto, v.7 ott.10;
- spunta l’un, l’altro matura, v.8 ott.10;
- tronco istesso e tra l’istessa foglia, v.1 ott.11;
- torta vite … orto aprico, v.6 ott.11;
- pendono a un ramo, un con dorata spoglia, / l’altro con verde, il novo e ‘l pomo antico, vv.3-4 ott.11;
- non par quella, / quella non par, vv.6-7 ott.14.
- spuntar la rosa / dal verde suo modesta e verginella, vv.1-2 ott.14 – metafora per indicare bella fanciulla;