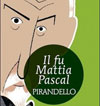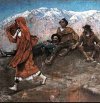La solitudine di Petrarca
Emerge in questa lirica il bisogno di solitudine e isolamento del poeta per poter continuare, immerso nel rassicurante rapporto con la natura, l’intimo e incessante colloquio con se stesso, alla ricerca di serenità ed equilibrio. Tuttavia il pensiero di Laura, la donna amata, torna senza posa a contrastare l’ansia di quiete di Petrarca.
TESTO
PARAFRASI
[1]
Solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l’arena stampi.
[1] Solo e pensieroso percorro (vo mesurando) i campi più deserti a passi lenti e stanchi (tardi), come se li misurassi, e guardo attentamente (gli occhi porto… intenti – iperbato e anastrofe) per evitare (per fuggire) [i luoghi] dove un'impronta umana (vestigio human – lat.) segni il terreno (arena stampi - anastrofe).
[5] Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’alegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:
[5] Non conosco (non trovo) altro riparo (schermo) che mi salvi (mi scampi) dal fatto che le persone (le genti) si accorgano facilmente (manifesto accorger) [del mio stato d’animo], poiché nell’atteggiamento (atti) privo di allegria (d’alegrezza spenti – anastrofe – spenti per metafora) si capisce (si legge - metafora) bene all'esterno (di fuor) come io bruci [d'amore] dentro (com’io dentro avampi):
[9] sì ch’io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.
[9] a tal punto che io credo (sì ch’io mi credo) che ormai i monti, le pianure (piagge), i fiumi e i boschi (selve) sappiano di quale qualità (tempre) sia la mia vita, che è celata agli altri (ch’è celata altrui – la vita intima nascosta alla curiosità della gente).
[12] Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co·llui.
[12] Ma tuttavia (pur) non so cercare strade così impervie (aspre) e isolate (selvagge) che Amore (Amor - personificazione) non venga sempre discorrendo (venga…ragionando - perifrasi) con me (con meco – meco = dal latino mecum significa già “con me”, in questo caso preceduto da con è una forma pleonastica), e io con lui (io co·llui - parallelismo).
Riassunto
Il poeta tutto preso dai suoi tristi pensieri passeggia solitario nei luoghi più deserti per nascondere agli altri uomini il suo intimo struggimento per amore. Tuttavia egli è consapevole che ovunque vada e per quanto selvaggi e solitari siano i luoghi in cui cerca rifugio, l’Amore lo insegue sempre ed egli non riesce a separarsi neanche per un breve momento dal pensiero di Laura, la donna amata.
Analisi del testo della poesia
Con una serie di opposizioni ed antitesi il poeta descrive il proprio dissidio interiore: inizialmente l’immagine è di solitudine assoluta in cui il poeta appare stanco e malinconico mentre nel suo intimo egli è invece agitato dal sentimento amoroso e nonostante egli ricerchi i luoghi più desolati e solitari non è mai completamente solo perchè sempre accompagnato dall’ossessione amorosa.
La lirica si sviluppa attorno a due tematiche che l’incipit (Solo et pensoso) evidenzia da subito. Nei due aggettivi che aprono la lirica c’è già virtualmente tutto il sonetto:
- la solitudine: l’isolamento e la fuga è la condizione a cui il poeta aspira perché ritenuta consona alla sua malinconia di innamorato. L’io fugge la socialità, vuole restare solo;
- la riflessione amorosa: restare solo con i propri pensieri permette al poeta di stare lontano dalla gente che non può capirlo e di sentire l’assidua presenza di Amore, che non lo abbandona mai e rappresenta nello stesso tempo un’ossessione ma anche un conforto.
Paesaggio
Il paesaggio non fa solo da sfondo alle vicende dell’io poetico ma è spettatore e testimone del travaglio interiore del poeta ed è la proiezione della sua condizione intima e dei sentimenti che egli prova.
La poesia stabilisce un rapporto diretto tra paesaggio e soggetto attraverso alcune corrispondenze tra gli elementi del paesaggio e la condizione del soggetto:
- il poeta cammina solo e malinconico e nello stesso modo i campi intorno a lui sembrano deserti (v.1);
- il poeta è triste (atti d’alegrezza spenti – v.7) e il paesaggio che lo circonda ha vie impervie e isolate (sì aspre vie né sì selvagge – v.12);
Del paesaggio vengono delineate solo le linee essenziali, non viene fatta una descrizione realistica. I riferimenti naturali sono infatti estremamente stilizzati, privi di ogni caratterizzazione realistica, in quanto Petrarca vuole insistere sul valore astratto, generalizzante e universale di questi luoghi del paesaggio che rappresentano, non un paesaggio reale, ma un paesaggio interiore, il paesaggio dell’anima del poeta (in ciò Petrarca anticipa il concetto del paesaggio/stato d’animo caposaldo della lirica moderna fino al romanticismo).
Amore
Amore è il protagonista della terzina finale.
La conclusione della lirica rivela così qual è la causa del comportamento del poeta e svela cosa egli voglia nascondere agli altri e che cosa voglia fuggire più ancora degli esseri umani: il proprio amore, l’amore per Laura che però non si lascia fuorviare e resta sempre e comunque con lui.
Analisi metrica
Sonetto, schema: ABBA ABBA CDE CDE.
La struttura della lirica appare di grande compattezza ed equilibrio, costruita su un gioco di simmetrie e corrispondenze basate su strutture binarie che rispecchiano la divaricazione spirituale del poeta. Le più importanti sono:
- le coppie di aggettivi e sostantivi, per esempio: solo e pensoso / tardi et lenti (vv.1-2); monti et piagge / et fiumi et selve (vv.9-10); aspre / selvagge (v.12)
- le antitesi (vedi nelle figure retoriche);
- i parallelismi, per esempio: con meco / con llui (v.14).
Il ritmo è lento e malinconico; la lentezza del verso sembra accompagnare il passo lento e cadenzato del poeta.
Rima derivata: campi/scampi (v. 1 e 5).
Figure retoriche
Oltre alle figure retoriche indicate nella parafrasi, vi sono:
- Polisindeto - …monti et piagge / et fiumi et selve… (vv. 9 e 10) – la serie di congiunzioni accelera il ritmo e suggerisce l’affanno del procedere inquieto del poeta;
- Climax – …monti/selve – piagge/fiumi…- (vv. 9 e 10);
- Antitesi – fuor-dentro (v. 8) – l’uso nello stesso verso di questi due termini antitetici mette in rilievo il tormentato e passionale mondo interiore del poeta; spenti-avampi (vv. 7-8) e più sfumata: schermo / manifesto vv.5-6.
- Allitterazione – della s e o: Solo et pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi (vv. 1-2); della r e s: …Ma pur sì aspre vie né sì selvagge… (v. 12).
- Enjambements – vv.1-2, 5-6, 9-10, 10-11, 12-13, 13-14. In particolare l’enjambement ai vv. 9 e 10 contribuisce a rendere il ritmo intermittente, unitamente al polisindeto richiamato sopra (et…et…et).