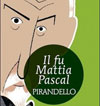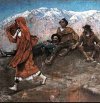In morte di Laura
Petrarca nel sonetto La vita fugge, et non s’arresta una hora mette in rima tutta la sua disperazione per la morte di Laura, evento che scatena la riflessione sull’impotenza dell’uomo a fermare il tempo che trascorre inesorabilmente.
Sono versi molto tristi e disperati da cui emerge anche il riferimento al suicidio per porre fine al proprio tormento.
TESTO
PARAFRASI
[1] La vita fugge, et non s’arresta una hora,
et la morte vien dietro a gran giornate,
et le cose presenti et le passate
mi dànno guerra, et le future anchora;
[1] La vita (personificazione e antitesi vita/morte) fugge e (et…et…et…et…e…et - polisindeto) non si ferma (arresta) neppure un attimo (hora), e (et…et - anafora) la morte (personificazione e antitesi morte/vita) la segue (vien dietro) a grandi passi (gran giornate - metafora), e il presente e il passato mi sono avversi (mi dànno guerra - metafora), così come anche (anchora) il futuro;
[5] e ’l rimembrare et l’aspettar m’accora,
or quinci or quindi, sí che ’n veritate,
se non ch’i’ ò di me stesso pietate,
i’ sarei già di questi penser’ fòra.
[5] e mi angoscia (m’accora) il ricordare (rimembrare - francesismo) [il passato] e l'aspettare (antitesi) [il futuro], da una parte e dall'altra (or quinci or quindi – riferiti rispettivamente a rimembrare e aspettare), sicché in verità (veritate), se non avessi pietà (pietate) di me stesso, io mi sarei già liberato da tutti questi pensieri (i’ sarei già di questi penser’ fòra - perifrasi per dire: mi sarei già ucciso).
[9] Tornami avanti, s’alcun dolce mai
ebbe ’l cor tristo; et poi da l’altra parte
veggio al mio navigar turbati i vènti ;
[12]veggio fortuna in porto , et stanco omai
il mio nocchier, et rotte arbore et sarte,
e i lumi bei che mirar soglio, spenti.
[12] vedo una tempesta nel porto (fortuna in porto – metafora - fortuna nel senso di fortunale) e (et…et…et…e - polisindeto) il mio timoniere (nocchier – metafora) ormai (omai) stanco, e spezzati l’albero maestro e le sartie (arbore et sarte - metafora), e spenti i begli occhi [di Laura] (lumi – metafora) che ero solito guardare (mirar soglio).
Riassunto del testo
- Prima quartina (vv.1-4): Il poeta parla della provvisorietà della vita e dell’incalzare della morte ed egli non trova consolazione, né guardando al passato ed al presente, né sperando nel futuro;
- Seconda quartina (vv.5-8): Petrarca ribadisce che sia guardare al passato che volgersi al futuro sono per lui fonte di grande angoscia, tanto che se non avesse avuto pietà di sé stesso, avrebbe già compiuto un gesto estremo;
- Prima terzina (vv.9-11): Il poeta si domanda, dubbioso, se nel passato abbia mai avuto momenti felici e vede il futuro come un mare in tempesta;
- Seconda terzina (vv.12-14): egli si sente come una nave in balia della burrasca anche stando nel porto, tutto si infrange ora che gli occhi dell’amata, suo punto di riferimento, sono spenti.
Tematica
Il tema centrale del sonetto La vita fugge et non s’arresta una hora si incentra sul trascorrere del tempo che inarrestabile porta all’ineluttabilità della morte.
La fugacità della vita e l’incombere della morte, nucleo fondamentale di questo componimento, sono temi ricorrenti in tutta l’opera di Petrarca, non solo nella sua produzione poetica.
Analisi della poesia
La vita fugge, et non s’arresta una hora è un sonetto che fa parte dei primi componimenti scritti da Petrarca in morte di Laura che sono raccolti nella seconda sezione del Canzoniere.
Il topos del tempo che fugge, ricorrente nell’opera poetica di Petrarca, viene inserito nella sua vicenda amorosa. La riflessione su questo tema è infatti conseguenza della morte di Laura, avvenimento che porta il poeta a fare un bilancio della sua intera esistenza e a considerare la caducità della vita umana.
Il sonetto è costruito su tre piani temporali richiamati nelle strofe centrali: il presente, il passato e il futuro. Nei confronti di tutte e tre le situazioni l’atteggiamento del poeta è negativo, in ognuno di essi vede dolore e fatica. Nulla può portargli conforto:
- né il passato tormentato,
- né il presente in cui prevale la stanchezza di vivere,
- né il futuro che vede senza speranze e prospettive.
L’ angoscia del poeta è quindi legata al tempo, al suo scorrere per non tornare più e alla prospettiva di un futuro dove senza Laura che rappresentava la sua luce, il suo faro, Petrarca si sente come un naufrago nel mare in tempesta.
L’ultima parola del sonetto: spenti, condensa dolorosamente tutta l’irrimediabilità della condizione dell’uomo.
Analisi metrica
Sonetto di 14 versi endecasillabi, ripartiti in 4 strofe con schema: rima ABBA (rima incrociata) nelle quartine, CDC (rima ripetuta) nelle terzine, dove la D riprende per assonanza la B delle quartine: parte, sarte in assonanza con giornate, passate, veritate, pietate.
Enjambement: vv.3/4; 9/10.
Petrarca usa vari latinismi, per es.: et, hora, anchora, veritate, pietate, fora, veggio, cor, arbore, lumi.
Le anafore, insieme ai polisindeti, contribuiscono a dare ritmo incalzante e veloce allo scorrere dei pensieri del poeta.
La poesia segue un andamento crescente nelle prime due strofe in un culmine di disperazione che poi decresce progressivamente nelle strofe successive nella rassegnazione e consapevolezza di un futuro senza prospettiva.
Figure retoriche
Approfondimento di alcune figure retoriche:
- veggio al mio navigar turbati i vènti / veggio – vv.11-12 - allitterazione lettere ve;
- et…et – vv.2-3;
- veggio…veggio – vv.11-12;
- non s’arresta una hora - v.1;
- Ò di me stesso pietate - v.7;
- I’ sarei già di questi penser’ fòra– v.8;
- s’alcun dolce mai/ ebbe ’l cor tristo – v.9-10;
- veggio al mio navigar turbati i vènti – v.11;
- mirar soglio – v.14;
- La vita fugge, et non s’arresta una hora, / et la morte vien dietro a gran giornate – vv. 1-2 – antitesi vita/morte;
- e ’l rimembrare et l’aspettar, v.5 – antitesi tra ricordare il passato e aspettare il futuro;
- et rotte arbore et sarte, / e i lumi bei che mirar soglio, spenti – vv.13-14 – un aggettivo (rotte) + due nomi (arbore - sarte) / un nome (lumi) + due aggettivi (bei - spenti);
- La vita fugge, et non s’arresta una hora , v.1 – Petrarca usa la negazione non s’arresta una hora per fare un’affermazione, cioè che il tempo scorre, la vita fugge;
il poeta esprime alcune metafore attraverso il linguaggio militare per manifestare il suo sentimento di lotta, di guerra nei confronti dell’inesorabile incalzare della morte:
- gran giornate, v.2 – gran giornate si riferisce alle marce militari in epoca romana che duravano giornate intere (magnis itineribus), si intende quindi che la morte arriva a marce forzate, molto velocemente;
- mi dànno guerra, v.4 – per dire: mi sono nemiche;
nella conclusione il poeta usa invece una serie di metafore con linguaggio nautico legate alla simbologia, già largamente utilizzata nel Duecento, che rappresenta la vita come navigazione. Petrarca paragona la sua vita al viaggio in una nave scossa dalla burrasca, in cui l’unica fonte di luce, di orientamento, da poter seguire è rappresentata dagli occhi della donna amata:
- mio navigar turbati i vènti, v.11 – il navigare è la vita del poeta piena di difficoltà;
- fortuna in porto, v.12 – anche adesso che la nave è in porto, cioè adesso che il poeta è nell’ultimo periodo della vita è ancora scosso dalle difficoltà (dal fortunale);
- il mio nocchier, et rotte arbore et sarte , v.13 – il nocchiero è colui che conduce la barca (nocchier), indica quindi la ragione che guida l’uomo mentre le sartie (i cordami) e l’albero maestro indicano la fortezza e le altre virtù dell’uomo;
- lumi, v.14 – indica gli occhi di laura;
- La vita fugge - v.1 – alla vita viene attribuita l’azione di fuggire come se fosse un essere vivente;
- la morte vien dietro a gran giornate, v.2 – idem per la morte che compie l’azione di marciare a grandi passi;
- …et…et…et…et - vv.1/5 e vv.12/13 – dà un ritmo incalzante;