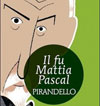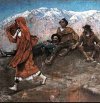ANTEFATTO
L’ottavo capitolo è il capitolo in cui si tenta la realizzazione degli inganni ideati nel cap.7, ovvero il matrimonio a sorpresa e contestualmente il rapimento di Lucia.
Il settimo capitolo si era concluso con il gruppetto di personaggi coinvolti nell’organizzazione del matrimonio a sorpresa (Renzo, Lucia, Agnese, Tonio e Gervaso) che si reca alla casa di don Abbondio per realizzare il piano concordato.
Arrivati alla canonica, mentre Renzo e Lucia rimangono nascosti, Tonio e il fratello chiedono alla Perpetua di essere ricevuti dal curato. In quello stesso momento, come stabilito, passa Agnese che finge di essere lì per caso.
Indice degli argomenti:
RIASSUNTO
A casa di don Abbondio
Nella canonica, don Abbondio è impegnato nella consueta lettura serale di un libro, quando la Perpetua gli annuncia la visita di Tonio e Gervaso. Nonostante l’ora tarda il prete acconsente a ricevere i due fratelli, per non lasciarsi sfuggire l’occasione di recuperare finalmente i soldi che questi gli devono.
La Perpetua, tornata sull’uscio per avvisare Tonio e il fratello che possono entrare e salire dal curato, viene intrattenuta da Agnese che, con mossa scaltra, usa la scusa di un pettegolezzo relativo a due vecchi spasimanti della donna, Beppe Suolavecchia e Anselmo Lunghigna, (che gira voce, non avessero voluto maritarsi con lei), per intrattenerla, inducendola a spiegarle la sua versione della vicenda.
Mentre le due donne si spostano in un luogo più appartato per parlare più liberamente, lasciando aperto l’uscio di casa, Agnese fa il segnale convenuto, tossendo forte, per dare il via libera ad entrare, ai due promessi sposi, rimasti sino ad allora nascosti.
Renzo e Lucia con cautela entrano nella casa del curato ed insieme ai due fratelli, che li aspettano all’entrata, salgono su per le scale fino alla stanza dove sta don Abbondio.
I fratelli entrano nella stanza mentre i promessi sposi rimangono sul pianerottolo, nascosti e appiattiti al muro.
Don Abbondio, dall’ aspetto trasandato, seduto su una vecchia seggiola, illuminato fiocamente da una piccola lucerna, accoglie i due fratelli con fastidio ribadendo di essere ammalato.
Tonio gli consegna un pacchettino contenente 25 berlinghe e gli chiede in cambio la collana della moglie data in pegno.
Don Abbondio controlla e ricontrolla le monete fino a persuadersi che è tutto corretto (senza difetto), dopo di che, con fare sospettoso, apre un armadietto prende la collana e la consegna a Tonio, richiudendo a chiave l’armadio.
Tonio chiede anche una ricevuta scritta che il curato controvoglia si appresta a scrivere, ripetendo ad alta voce le parole messe sul foglio, mentre i due fratelli si mettono diritti davanti a lui in modo da togliergli la visuale sull’uscio.
A quel punto, al segnale convenuto dello stropiccio delle scarpe sul pavimento, Renzo e Lucia entrano nella stanza nascondendosi dietro ai due fratelli che, avuta la ricevuta, si spostano rispettivamente ognuno sul proprio lato, lasciando apparire le figure dei due promessi sposi.
Renzo senza perdere tempo, con impeto, recita le parole di rito che dichiarano Lucia sua moglie davanti ai due testimoni.
Dopo lo stupore iniziale don Abbondio, con altrettanto impeto, reagisce infuriandosi e ribaltando tutto ciò che sta sulla sua scrivania davanti a lui, tirando il tappetino che la ricopre e buttandolo addosso a Lucia, che rimasta imprigionata nella tela e impossibilitata a pronunciare a sua volta la formula di rito. Approfittando di questa pausa il curato fugge quindi a nascondersi nella stanza attigua dove si chiude a chiave, invocando l’aiuto della perpetua e intimando agli intrusi di andarsene.
Nello studio, rimasto al buio dopo che la lampada che stava sulla scrivania è caduta, tra i personaggi regna una grande confusione:
- Renzo, inseguito il curato nella stanza accanto, picchia manate sulla porta esortandolo ad uscire;
- Lucia, a bassa voce, chiede a Renzo di andarsene da lì;
- Tonio, carponi, cerca la sua ricevuta caduta chissà dove;
- Gervaso si muove forsennato cercando la porta d’uscita.
Il narratore inserisce in questo punto del racconto una sua considerazione in cui invita il lettore a riflettere su come siano cambiati i ruoli dei personaggi e su chi sia, in questa situazione, l’oppressore e chi l’oppresso, rilevando come:
- l’oppresso, cioè Renzo, visto in questa scena in cui urla tenendo sotto assedio il curato, appaia invece come l’oppressore
- mentre il vero oppressore, ovvero don Abbondio, assediato nella sua casa, indossi adesso le vesti dell’oppresso.
Il curato, in cerca di aiuto, si affaccia alla finestra urlando e chiedendo di essere soccorso. La notte è limpida, illuminata dalla luna, nelle strade non si vede anima viva ma le urla svegliano il sagrestano che spaventato dalle richieste di aiuto di don Abbondio, decide di andare al campanile a suonare la campana per allertare tutto il paese.
I rintocchi svegliano i contadini che accorrono numerosi, alcuni di loro sono armati di forche e schioppi.
Il frastuono allarma però anche:
- I bravi
- Agnese e la Perpetua
Mentre questa scena ha luogo, in un’altra zona del paese, i bravi erano entrati in azione per rapire Lucia.
A casa di Agnese e Lucia
Il gruppetto dei bravi che erano rimasti alla locanda si erano riuniti, al far della sera, con tutti gli altri e con Griso, il loro capo, che erano appostati al casolare.
Si erano diretti quindi alla casa di Agnese e Lucia per attuare il piano del rapimento della ragazza, proprio nello stesso momento in cui le due donne, insieme a Renzo e ai due testimoni (Tonio e Gervaso), usando una strada diversa, si erano mossi per recarsi dal curato a realizzare il matrimonio a sorpresa.
Griso e suoi uomini inconsapevoli del fatto che ormai in casa non c’era più nessuno, muovendosi guardinghi e cercando di fare meno rumore possibile, erano entrati in ogni stanza non trovando però nessuno.
I due bravi rimasti a guardia sull’uscio di casa, ad un certo momento, sentirono i passi di qualcuno che si avvicinava alla casa.
Era Menico, mandato da Padre Cristoforo che saputo dal servitore di don Rodrigo della spedizione del Griso, voleva avvisare Lucia ed Agnese del pericolo e suggerirgli di andarsene da casa per rifugiarsi in convento.
Menico trovato aperto l’uscio, timoroso e sospettoso entrò e all’improvviso venne assalito dai due bravi e lanciò un urlo mentre i due bravi gli tappavano la bocca e lo minacciavano.
E’ proprio in quel momento che esplode in tutto il suo fragore la tempesta di rintocchi di campana che il sagrestano ha attivato in risposta alle richieste di aiuto di don Abbondio, provocando in tutti un grande spavento.
I due bravi, sorpresi e impauriti, lasciano immediatamente Menico, che scappa verso il campanile, e corrono a raggiungere gli altri del gruppo all’interno della casa. Mentre nella casa si è scatenato lo scompiglio, tutti corrono e cercano, nella confusione generale, la via più breve per uscire e scappare.
Solo grazie all’energico intervento di Griso che, come un cane pastore che riunisce il gregge, riesce a domare la scomposta fuga dei bravi, il drappello dei briganti esce in buon ordine prendendo la strada che porta fuori dal paese.
La Perpetua e Agnese
Agnese, per favorire il progetto del matrimonio a sorpresa, aveva cercato, tra una chiacchiera e l’altra, di allontanare il più possibile la Perpetua dalla canonica ma quando la Perpetua si era ricordata dell’uscio lasciato aperto ed aveva insistito per ritornare, Agnese per non destare sospetti l’aveva seguita cercando in qualche modo di rallentarne il rientro, cercando di stuzzicare la Perpetua a continuare il suo racconto, chiedendole i vari particolari.
Le due donne erano abbastanza vicine a casa, anche se ancora non scorgevano l’abitazione, quando sentirono la richiesta d’aiuto del curato. La Perpetua allarmata, nonostante Agnese tentasse ancora di distrarla e trattenerla, non volle più sentire ragioni e si affrettò a rientrare alla canonica.
Anche Agnese ha motivo di allarmarsi sentendo echeggiare un altro urlo, più lontano e più acuto, e riconoscendo in quell’urlo la voce di Menico (era lei che aveva mandato il ragazzo da Fra Cristoforo per avere notizie su cosa fosse successo da don Rodrigo).
Dopo le urla si sentono anche i rintocchi della campana. La Perpetua arrivata alla canonica fa per spingere l’uscio quando questo si spalanca e ne escono Tonio, Gervaso, Renzo e Lucia che fuggono senza rispondere alle domande che la Perpetua, stupita, rivolge loro. La donna non insiste ritenendo più importante correre da don Abbondio.
I due promessi sposi nella fuga si trovano davanti Agnese che affannata gli chiede come sia andata, Renzo le dice solo di dirigersi tutti a casa prima che arrivi gente ma sulla via incontrano Menico che gli racconta che a casa non si può andare e che anche fra Cristoforo vuole che vadano tutti al convento.
Così il gruppetto entra in una stradina che sta tra la chiesa e la casa di don Abbondio e da lì prende la via dei campi.
Nel frattempo, la piazza della chiesa si riempie di gente che agitata domanda il perché di quei rintocchi.
Ambrogio, il sacrestano, smette allora di suonare la campana e riferisce che l’allarme è dovuto alla presenza di persone in casa del curato.
Il paese si mobilita
Tutti i paesani si avvicinano alla casa del curato ma lì tutto è silenzio. Infatti, don Abbondio appena scampato il pericolo aveva richiuso la finestra. Ora pentito di aver richiesto aiuto, per l’eccessivo clamore che ne era derivato, risponde alle domande dei suoi fedeli cercando di minimizzare la cosa, evitando di toccare il tasto dei promessi sposi e accennando, con fare vago, che si trattava di brutta gente che gli era entrata in casa e che però era scappata.
La folla delusa si sta disperdendo quando appare, affannato, il dirimpettaio della casa di Agnese che dalla sua finestra aveva visto la scena dello scompiglio dei bravi e del Griso che cercava di coordinarli. Avvisa che il pericolo (il diavolo) non è lì in paese ma alla casa di Agnese dove stanno uccidendo un pellegrino, e chiede del console del paese.
Il console risponde all’appello dell’uomo e cerca di coordinare l’intervento ma senza successo e giunge al luogo indicato con la folla che si muove in massa, alla rinfusa e in maniera convulsa.
La casa è deserta ma le tracce dell’assalto dei banditi sono ancora fresche: l’uscio è spalancato e la serratura divelta. Tutti urlano a gran voce i nomi di Lucia e Agnese ma nessuno risponde, si pensa di conseguenza che siano state rapite e il tumulto cresce.
Finchè qualcuno - uno (e non si seppe mai bene chi fosse stato) gettò…una voce, scrive l’autore lasciando intendere che fosse un bravo – dice che Lucia e Agnese si erano messe in salvo e ciò è sufficiente perché tutto si calmi, il gruppo si sparpaglia e ognuno torna alla propria casa.
Il giorno dopo il console è nei campi a zappare e rimugina su quanto accaduto nella notte, ragionando sul fatto che dovrebbe dare un seguito alla vicenda, denunciare l’accaduto ad un superiore, quando vede venirgli incontro due bravi che con toni bruschi gli intimano di non fare rapporto al podestà di quanto accaduto e di non farne parola a nessuno.
La fuga verso il convento
Il gruppetto dei fuggiaschi camminando con passo veloce, in silenzio, si guarda indietro di tanto intanto per controllare di non essere seguito mentre il suono delle campane si fa sempre più lontano finché cessa.
Quando si trovano in aperta campagna, con nessuna abitazione nei dintorni, rallentano il passo e Agnese per prima comincia a parlare chiedendo a Renzo cosa fosse successo dal curato e a Menico quanto accaduto nella casa.
Dopo le spiegazioni tutti si stringono intorno a Menico ringraziandolo, tacitamente consapevoli del pericolo corso dal ragazzo.
Agnese gli dà le due parpagliole promesse per la commissione che gli aveva affidato e ne aggiunge altre 2, dicendogli di rientrare a casa per non destare preoccupazioni nei suoi genitori.
Anche Renzo gli regala una berlinga, raccomandandogli di non fare parola dell’accaduto e Lucia lo accarezza, affettuosa e riconoscente.
Menico se ne va e gli altri riprendono il loro cammino sino ad arrivare alla piazzetta davanti alla chiesa del convento.
Al convento
Renzo spinge la porta della chiesa che immediatamente si apre perché subito dietro di essa c’è padre Cristoforo che, constatato che c’erano tutti, trae un sospiro di sollievo e li fa subito entrare.
Padre Cristoforo non è solo, accanto a lui c’è il frate laico Fazio, addetto alla sagrestia.
Il sagrestano è preoccupato ed esterna borbottando tutti i suoi dubbi sulla liceità di quella situazione, in cui di notte, in maniera furtiva e fuori dalle regole, è concesso a queste persone di entrare in chiesa.
Tra sé e sé il padre non può fare a meno di considerare che certamente Frate Fazio se si fosse trattato di un masnadiero, sostenuto dai potenti, non avrebbe sicuramente avanzato tutte le obiezioni che invece solleva e dimenticandosi che un sempliciotto come fra Fazio non conosce il latino, replica dicendo: “Omnia munda mundis”. Inaspettatamente a quelle parole così misteriose fra Fazio desiste dall’insistere con le sue obiezioni.
Padre Cristoforo, ignaro di quanto successo in paese, del tentativo di matrimonio e dell’imboscata fallita dei bravi, convinto che Menico avesse trovato i suoi protetti tranquilli in casa e li avesse convinti a raggiungerlo in convento, si rivolge quindi ai fuggiaschi, spiegandogli la situazione. Nessuno dei fuggiaschi ha il coraggio di informarlo su quanto accaduto, neppure Lucia.
Il padre afferma che per loro non è più possibile, per ora, tornare al paese, alle loro case, è troppo pericoloso, per cui propone che Lucia e Agnese vadano in un convento non troppo lontano, dove verranno accolte dal padre guardiano, mentre Renzo troverà rifugio in un altro convento a Milano.
Sulla riva del lago troveranno un battello pronto per loro che li porterà sull’altra riva e da lì un baroccio che li porterà al convento.
Prima della partenza fra Cristoforo chiede che tutti preghino insieme e lo facciano anche per colui che ha causato quella situazione.
Poi in fretta congeda il gruppetto soggiungendo che il suo cuore gli dice che presto si sarebbero rivisti.
L'addio ai monti
Arrivati al lago i tre fuggiaschi trovano il battello che li aspetta, scambiate le parole convenute, salgono e il barcaiolo inizia a remare verso la riva opposta.
Tutt’intorno è silenzio e pace, il lago è piatto e liscio e la notte chiara.
I passeggeri sono silenziosi, voltati all’indietro guardano i luoghi da cui stanno, a malincuore, allontanandosi. Vedono i monti, il paesello, la chiesa rischiarati dalla luce della luna che permette di distinguere chiaramente tutto, vedono anche il palazzotto di don Rodrigo che svetta minaccioso su tutte le casette circostanti.
Renzo, Lucia e Agnese, per sottrarsi a don Rodrigo abbandonano uno scenario che rappresenta tutta la loro vita, i loro ricordi, le loro aspirazioni, i loro sogni.
Lucia con una dolcezza e tristezza crescente vede il paese, la sua casetta, la chioma folta del fico, la finestra della sua camera e di nascosto china la testa e piange silenziosamente.
Da quel paesaggio natio che si allontana in Lucia si leva un accorato addio alle sue terre carico di rimpianto. I pensieri che affollano la sua mente, mentre la barca si avvicina alla sponda opposta, sono poco diversi dai pensieri di Renzo e Agnese.
ANALISI DEL TESTO
L’ottavo capitolo è noto come il capitolo della notte degli inganni o imbrogli. A cosa si riferisce?
Si fa riferimento al fatto che durante quella notte vengono tentati, in simultanea, due diversi tipi di imbrogli:
- Renzo, Lucia e Agnese cercano di mettere in pratica il piano del matrimonio a sorpresa, mettendo don Abbondio alle strette per costringerlo a celebrare le nozze;
- I bravi al comando di don Rodrigo cercano di rapire Lucia.
La narrazione si presenta con l’intreccio di queste vicende la cui simultaneità viene resa attraverso l’uso di analessi (flashback) e parallelismi. L’analogia delle situazioni viene sottolineata anche attraverso l’uso di termini simili, per esempio:
- Nel matrimonio a sorpresa: vennero avanti, rasentando il muro, zitti zitti; arrivarono all’uscio, lo spinsero adagino adagino;
- Nel tentativo di rapimento: passarono anche, pian piano…scalar adagino il muro…picchiò pian piano…sconficcare adagio il paletto..accosta adagio adagio l’uscio..spinge mollemente l’uscio;
Gli inganni falliscono entrambi:
- Il matrimonio fallisce per la fulminea reazione di don Abbondio;
- Il rapimento per l’intervento del caso.
INCIPIT
L’apertura del capitolo mette in rilievo l’ignoranza e la mediocrità di don Abbondio che durante la sua consueta lettura serale, trova un riferimento a Carneade [filosofo e oratore del II secolo a.C.] e si domanda chi possa essere costui: “Carneade! Chi era costui?”.
D'altra parte, come viene precisato da Manzoni, il curato legge per abitudine, per ammazzare il tempo, non per passione ed il suo criterio di scelta dei libri è completamente casuale cadendo solitamente sul primo libro che gli capita tra le mani.
LE INTERIEZIONI
Interessante l’uso delle interiezioni con cui Manzoni colorisce le parole del curato:
- Ehi! Ehi! del dialogo con la Perpetua: Ehi! Ehi! Siete poi ben sicura che sia proprio lui?;
- Tonio eh? con cui don Abbondio accoglie Tonio: Tonio eh? Entrate;
- Ah! Ah! di saluto a Tonio: “Ah! Ah!” Fu il suo saluto, mentre si levava gli occhiali, e li riponeva nel libricciolo;
- Ih! della frase di risposta alla richiesta di una ricevuta da parte di Tonio: Ih! com’è divenuto sospettoso il mondo!.
DON ABBONDIO
Il ritratto di don Abbondio sottolinea una volta di più la miseria del personaggio:
- La descrizione fisica punta a trasmettere la trasandatezza del personaggio così come squallido è lo sfondo dello studio in cui si trova;
- Vengono messi in rilievo anche le sue lente abitudini e i comportamenti, come il fare sospettoso e d’avaro, che meticolosamente conta e riconta i soldi consegnategli da Tonio, tutte caratteristiche perfettamente in tono con i tratti psicologici del personaggio.
- Solo quando la diffidenza di don Abbondio si affievolisce ed egli è soddisfatto per aver recuperato i suoi soldi, Manzoni gli fa apparire Renzo e Lucia e la calma meticolosa della scena si infrange nella repentina reazione del curato, reazione fulminea che appare in netto contrasto con la lentezza e la codardia del personaggio visto nel primo capitolo durante l’incontro con i Bravi.
- Tutta la viltà di don Abbondio si ripresenta quando arriva il soccorso dei paesani, troppo rumorosi e numerosi, ed egli, persa la sua furia, si ritira nell’evasività, minimizza perché non ha alcun interesse a far emergere la questione dei promessi sposi.
ALTRI PERSONAGGI
I bravi
I bravi non hanno un nome ma solo un soprannome:
- Griso;
- Grignapoco;
- Nibbio;
- Tiradritto;
- Tanabuso;
- Montanarolo.
I soprannomi non sono scelti a caso ma ben studiati da Manzoni con intenti ritrattistici.
Perpetua e Agnese
Il dialogo tra Agnese e la Perpetua è un dialogo tra comari che tende al farsesco con la scelta dei cognomi di Suolavecchia e Lunghigna, quali spasimanti della perpetua.
Il sagrestano fazio
Il personaggio di Fazio, il sagrestano del convento, appartiene alla schiera di quelli che piegano volentieri il capo davanti alla prepotenza del potere. E’ un chiacchierone ed un ignorante.
ANDAMENTO DEL RACCONTO
Due i centri del capitolo:
- Il tentato matrimonio in casa di don Abbondio;
- Il tentato rapimento di Lucia in casa di Agnese.
Il capitolo è un alternarsi di tumulti e di calma, di urla e di silenzi che conferiscono al testo un ritmo quasi musicale in cui i vari movimenti si susseguono passando: dal piano all’andante, all’andante con moto sino al pianissimo.
L’andamento tumultuante caratterizza la prima parte del capitolo, con intreccio e varietà di temi, che Manzoni rende attraverso uscite ed immagini come:
- La scena del parapiglia che si scatena nel buio quando don Abbondio scappando dallo studio rovescia la lanterna e tutti i personaggi si muovono brancolando nell’oscurità;
- Il personaggio minore del sagrestano Ambrogio che risvegliato dal suo sonno dalle urla si appallottola i pantaloni sotto il braccio, come fossero un cappello di gala, e corre a precipizio al campanile.
- L’immagine della piazza che si popola dei contadini svegliati dal rintocco delle campane in cui la concitazione della scena rivela la psicologia della folla.
- Lo stupore del Griso e dei bravi nel trovare la casa di Agnese e Lucia vuota e quello si Menico che trova l’uscio aperto.
- I bravi che piombano su Menico, immobilizzandolo.
- Il parapiglia che si scatena tra i bravi al suono della campana d’allarme simile in rapidità e concatenazione alle mosse degli assalitori di don Abbondio.
- Le urla, prima di don Abbondio, poi di Menico che rompono la pace del villaggio immerso nel silenzio notturno. Urla che si congiungono con i rintocchi della campana di allarme, amplificandone l’effetto.
Inframezzati a questi momenti caotici vi sono momenti di quiete, di silenzio e di pausa che creano una sospensione che prepara la successiva concitazione della scena.
Il momento più drammatico del capitolo è costituito dagli urli, prima quello di don Abbondio, poi quello di Menico che echeggiano nel vasto spazio notturno che sembra espandere le onde sonore ed evidenzia il silenzio di quella notte di villaggio.
SEQUENZE NARRATIVE
Si possono individuare 5 sequenze narrative:
- Il fallito tentativo di matrimonio a casa di don Abbondio;
- Il fallito rapimento di Lucia da parte dei bravi a casa di Agnese e Lucia;
- La massa di paesani che accorre al suono dei rintocchi della campana;
- L’incontro tra i fuggitivi e padre Cristoforo alla chiesa del convento;
- L’abbandono del paese e l’addio ai monti.
Le prime due sequenze procedono per paralleli:
- la sorpresa in casa di don Abbondio è parallela alla sorpresa in casa di Lucia,
- le mosse dei bravi sorpresi dalla campana d’allarme si susseguono e concatenano con la stessa rapidità e goffaggine delle mosse degli assalitori di don Abbondio,
- la fine della spedizione dei bravi si ricongiunge con la fine della parallela spedizione di Renzo e Lucia, l’una e l’altra falliscono contemporaneamente.
Le prime due sequenze hanno i tratti della commedia con scene vicine alla rappresentazione comica, mentre le altre tre sequenze sono quadretti assai diversi tra loro:
- Vivace e mossa la scena della folla dei paesani allarmati;
- Solenne la scena incentrata su padre Cristoforo che accoglie i fuggitivi e che si conclude con la preghiera di perdono per il nemico;
- Intensa ed emotiva la scena paesaggistica che chiude il capitolo.
CONCLUSIONE
Il capitolo VIII si conclude con il noto brano comunemente conosciuto come “Addio ai monti”. E’ il doloroso commiato dei protagonisti dalla propria terra mentre una barca li trasporta sull’altra sponda del lago.
La chiusa è malinconica e sommessa, nel paesaggio lacustre tutto è silenzio, pacatezza e pace. Anche i fuggiaschi, dopo tante trepidazioni e spaventi, diventano passeggeri silenziosi e assorti a guardare il loro paesello ed i monti.
Il paesaggio visto da Renzo, Agnese e Lucia, dalla barca che si allontana dalla riva, è la loro vita intera, i loro ricordi, sogni e aspirazioni sono tutti in quei luoghi, quei monti, quei paesini, quelle case, quel lago.
ADDIO AI MONTI
Nel brano Addio ai monti lo sguardo sul paesaggio notturno è inizialmente quello di tutti e tre i personaggi che dalla barca in mezzo al lago si voltano a guardare i luoghi che sono costretti ad abbandonare, per poi diventare il punto di osservazione solo di Lucia, la descrizione si focalizza solo sulle parti più significative per lei, perché a lei più care (paesello, casetta, fico, muro del cortile, finestra della sua camera) e quando ella china la fronte sul proprio braccio e piange la descrizione prosegue attraverso i suoi pensieri e i suoi ricordi.
Le parole di Lucia hanno un ritmo pacato e semplice così come le immagini che riproduce nei suoi pensieri.
Lucia, che per tutto il capitolo si è distinta come il personaggio più silenzioso, in una vicenda particolarmente rumorosa e tumultuosa, anche nell’atteggiamento finale, quando lascia la sua casa e la terra natia, mantiene un composto abbandono che si manifesta nel pianto sommesso e intimo. Tra i vari personaggi, Lucia emerge come protagonista che patisce in mezzo agli altri che agiscono.
L’Addio non chiude solo il capitolo ma anche tutta la prima parte del romanzo. Inoltre, da questo momento i due promessi sposi vivranno vicende separate sino al loro ricongiungimento alla conclusione del libro.
Il momento più drammatico del capitolo è costituito dagli urli, prima quello di don Abbondio, poi quello di Menico che echeggiano nel vasto spazio notturno che sembra espandere le onde sonore ed evidenzia il silenzio di quella notte di villaggio.
TECNICA DESCRITTIVA DEL BRANO "ADDIO AI MONTI"
L’Addio stilisticamente si stacca dal resto del racconto e assume l’andamento di una lirica.
Il brano ha un ritmo melodico reso attraverso:
- strofe ineguali, endecasillabi, settenari tronchi, ottonari e decasillabi;
- rime (sorgenti; torrenti; pascenti)
- ripetizioni e insistenze (Addio…Addio…Addio…Addio…; chi non aveva mai spinto…chi aveva composti…chi staccato ad un tempo…; casa natia…casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte…; dove l’animo tornò…dov’era promesso…dove il sospiro…).
Nell’Addio ai monti la descrizione passa progressivamente dallo sguardo esterno a quello interno che culmina nell’intima riflessione di Lucia ripiegata su se stessa e singhiozzante dove i luoghi e lo stato d’animo si fondono insieme in un coacervo di emozioni.
Nel brano si susseguono sequenze puramente descrittive, quindi oggettive, con sequenze soggettivo-emotive, cariche di elementi sentimentali ed emozionali che esprimono lo stato d’animo del personaggio nei confronti del luogo descritto.
Gli aspetti del paesaggio vengono percepiti non solo attraverso il senso della vista ma anche attraverso il senso dell’udito, suoni e rumori fanno parte della descrizione (il lento frangersi…il gorgoglio…il tonfo…ecc.).
L’oggettiva descrizione del paesaggio è carica di elementi affettivi e intimi che rivelano ciò che i personaggi provano per quei luoghi, per questo il brano Addio ai monti viene definito un esempio di testo descrittivo letterario di tipo soggettivo-emotivo.
Questa tecnica descrittiva lirico-soggettiva serve a coinvolgere il lettore nell’atmosfera vissuta dai personaggi.
IL CHIARO DI LUNA
La luce della luna, citata più volte nel capitolo, è la notazione luministica richiamata in varie sequenze che rischiara la scena, conferendole spesso pace e tristezza.
La troviamo nella descrizione:
- del volto di don Abbondio: Due folte ciocche di capelli, che gli scappavano fuor della papalina, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti, e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo, al chiaro di luna;
- della piazza dove crea una pausa di silenzio e di pace dopo la turbolenza seguita al tentativo di matrimonio a sorpresa: Era il più bel chiaro di luna; l’ombra della chiesa, e più in fuori l’ombra lunga ed acuta del campanile, si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza: ogni oggetto si poteva distinguere, quasi come di giorno;
- del viso di padre Cristoforo: la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida, e la barba d’argento del padre Cristoforo;
- del lago visto della barca che trasporta i fuggitivi: il lago giaceva liscio e piano, e sarebbe parso immobile, se non fosse stato il tremolare e l’ondeggiar leggiero della luna.
- dei monti e del paese visti dalla barca: I passeggieri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti, e il paese rischiarato dalla luna, e variato qua e là di grand’ombre.
In particolare, nelle descrizioni relative ai paesaggi l’impressione che emerge è di silenzio, di lentezza e di malinconia.
FIGURE RETORICHE
Diverse le figure retoriche, alcuni esempi:
- sconficcar bel bello il chiavistello per di dentro…;
- Renzo si fece alla porta della chiesa, e la sospinse bel bello.;
- il Griso sale adagio adagio…;
- padre Cristoforo richiuse la porta adagio adagio.;
- don Abbondio stava … su una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina –ripetizioni che mettono in evidenza la trascuratezza del personaggio;
- due folte ciocche di capelli … due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti;
- Addio, casa natia…Addio, casa ancora straniera…Addio, chiesa…addio! – la ripetizione sottolinea luoghi ed emozioni e accresce la suggestione emotiva della formula di commiato;
- chi non aveva mai spinto…chi aveva composti…chi staccato ad un tempo…;
- casa natia…casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte…;
- Chi strappato ad un tempo alle più care abitudini, e sturbato nelle più care speranze…;
- dove l’animo tornò…dov’era promesso…dove il sospiro…;
- Ciò fatto, picchiò sommessamente, con intenzione di dirsi un pellegrino smarrito;
- Oh la bugiarda! la bugiardona! – climax ascendente per denotare la reazione della perpetua ai pettegolezzi sul suo conto;
- intravvide, vide, si spaventò, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione - lo stupore e l’agitazione di don Abbondio quando gli appaiono Renzo e Lucia è reso attraverso il climax ascendente;
- Non senza rossore – Lucia ricordando quando passava davanti a casa di Renzo esprime un’immagine attraverso la negazione del suo contrario;
- con in capo una vecchia papalina, che gli faceva cornice intorno alla faccia – elemento che caratterizza la descrizione di don Abbondio;
- Due folte ciocche di capelli…due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo…potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve – l’aspetto di don Abbondio viene reso buffo attraverso la descrizione;
- barba d’argento – abbellisce la descrizione di padre Cristoforo;
- ton, ton, ton, ton - Riproduce il suono martellante della campana;
Similitudine – le similitudini sono numerose e rendono più suggestiva la descrizione:
- poteva parere una statua abbozzata in creta, sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno – descrizione di Lucia che, avvolta nella tovaglia che don Abbondio le ha gettato addosso da cui non riesce a liberarsi, sembra una statua avvolta in un panno;
- Come al dividersi di una scena, apparvero Renzo e Lucia – i due promessi sposi appaiono davanti al curato come all’aprirsi di un sipario;
- Come il cane che scorta un gregge di porci corre or qua or là a quei che si sbandano, ne addenta uno per un’orecchia e lo tira in ischiera, ne spinge un altro col muso, abbaia ad un altro che esce di fila in quel momento…tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto. – paragona il Griso al cane pastore che con fatica tiene insieme il gregge;
- e sarebbe una vergogna per il paese, se ogni birbone potesse a man salva venire a portar via le donne, come il nibbio i pulcini da un'aia deserta – paragona il rapitore con un rapace;
- ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti – nella descrizione che Lucia fa dei luoghi natii vi sono diverse similitudini, oltre a questa che paragona le case a pecore al pascolo, come le voci dei suoi cari (come il suono delle voci domestiche) che sembrano il rumore dell'acqua che scorre nel fiume o ancora quando ricorda i profili delle montagne che sono paragonate al volto dei suoi parenti;
- Il garzoncello trema come una foglia – fa riferimento a Menico che sorpreso dai bravi nella casa di Lucia ed Agnese è molto spaventato.