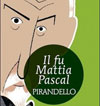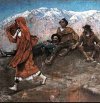Compianto per la sconfitta
Ahi lasso, or è stagion de doler tanto, celebre canzone civile di compianto ai fiorentini per la sanguinosa sconfitta subita a Montaperti (1260), in cui emerge la prospettiva municipale del guelfo Guittone d’Arezzo, il suo impegno civile, la sua passione politica e tutto il suo sarcasmo.
TESTO
PARAFRASI
[1]
Ahi lasso, or è stagion de doler tanto
a ciascun om che ben ama Ragione,
ch’eo meraviglio u’ trova guerigione,
ca morto no l’ha già corrotto e pianto,
vedendo l’alta Fior sempre granata
e l’onorato antico uso romano
ch’a certo pèr, crudel forte villano,
s’avaccio ella no è ricoverata:
ché l’onorata sua ricca grandezza
e ’l pregio quasi è già tutto perito
e lo valor e ’l poder si desvia.
Oh lasso, or quale dia
fu mai tanto crudel dannaggio audito?
Deo, com’hailo sofrito,
deritto pèra e torto entr i ’n altezza ?
[1] Ahimè (Ahi lasso – lasso è dal latino lassus = stanco), questo è il momento (stagion - metafora) di soffrire (de doler) tanto per ogni (a ciascun) uomo (om - latinismo) che ama veramente (ben) la Giustizia (Ragione - personificazione), a tal punto che (ch’eo – eo latinismo) mi meraviglio che trovi (u’ trova – u’ sta per il latino ubi = dove) conforto (guerigione), e che (ca – latinismo da quia) la sofferenza (corrotto) e il pianto non l'abbiano già ucciso (morto no l’ha già), vedendo la nobile (l’alta) Firenze (Fior – metafora e metonimia) sempre fiorente (granata – latinismo da granatam = ricca di semi) e l’antico onorato costume (uso – latinismo da usus) romano che certamente (ch’a certo) muoiono (pèr – sta per perisce - latinismo), crudeltà (crudel) assai (forte) zotica (villano – latinismo – indica lo zotico), se essa (ella = Firenze) non è soccorsa (ricoverata) in fretta (avaccio – dal provenzale viazo = presto): dato che (ché) la sua onorata e ricca grandezza e il (’l) [suo] prestigio sono (è) già quasi tutti estinti (tutto perito) e il valore e il potere (’l poder) se ne vanno (desvia – latinismo – de+via = deviare).
Ahimè (Oh lasso), in quale giorno (or quale dia – dia è forma provenzale e siciliana) si è mai sentita (fu mai…audito – audito è latinismo) una sventura (dannaggio - provenzalismo) tanto crudele? [domanda retorica]
O Dio (Deo - apostrofe), come lo hai (com’hailo - anastrofe) tollerato (sofrito – dal latino subfero) [che] muoia (pèra – dal latino pereat) il diritto e l'ingiustizia (torto) trionfi (entri ’n altezza - perifrasi)? [domanda retorica]
[16] Altezza tanta êlla sfiorata Fiore
fo, mentre ver’ se stessa era leale,
che ritenea modo imperïale,
acquistando per suo alto valore
provinci’ e terre, press’o lunge, mante;
e sembrava che far volesse impero
sì como Roma già fece, e leggero
li era, c’alcun no i potea star avante.
E ciò li stava ben certo a ragione,
ché non se ne penava per pro tanto,
como per ritener giustizi’ e poso;
e poi folli amoroso
de fare ciò, si trasse avante tanto,
ch’al mondo no ha canto
u’ non sonasse il pregio del Leone.
[16] Vi fu (fo) tanta grandezza (Altezza tanta) nella (êlla = en la) decaduta (sfiorata – in antitesi con altezza) Firenze (sfiorata Fiore – allitterazione e metafora) finchè (mentre ) è stata (era) leale verso se stessa, poiché (che) aveva (ritenea) un contegno (modo – latinismo da modus) imperiale, conquistando (acquistando) grazie al (per) suo alto valore numerose (mante - gallicismo) regioni (provinci’) e città (terre), vicine o lontane (press’o lunge – presso è latinismo); e sembrava che volesse creare (far) un impero così (sì) come (como) in passato (già) fece Roma, e le (li) sarebbe stato facile (leggero…era), poiché nessuno (c’alcun) le (i) poteva stare davanti (star avante – avante dal latino ante).
E ciò le (li) avveniva (stava) certamente (ben certo) a buon diritto (a ragione), poiché (ché) non si dava affanno (penava) tanto (tanto – rima univoca/equivoca con tanto v.28) per [il suo] vantaggio (pro – latinismo), quanto (como) per mantenere (ritener) giustizia e pace (giustizi’ e poso – poso è latinismo); e poiché (poi) le fu (folli amoroso – folli = li fo = gli fu) piacevole (amoroso) fare questo, si spinse (si trasse) tanto avanti, che al mondo non c'è (no ha) angolo (canto – dal greco kanthos) dove (u’ – da latino ubi) non risuonasse (sonasse) il prestigio di Firenze (Leone – metafora e metonimia - il Mazzocco simbolo araldico di Firenze – è un leone che tiene con la zampa lo scudo con il giglio).
[31] Leone, lasso, or no è, ch’eo li veo
tratto l’onghie e li denti e lo valore,
e ’l gran lignaggio suo mort’a dolore,
ed en crudel pregio[n] mis’ a gran reo.
E ciò li ha fatto chi? Quelli che sono
de la schiatta gentil sua stratti e nati,
che fun per lui cresciuti e avanzati
sovra tutti altri, e collocati a bono;
e per la grande altezza ove li mise
ennantir sì, che ’l piagãr quasi a morte;
ma Deo di guerigion feceli dono,
ed el fe’ lor perdono;
e anche el refedier poi, ma fu forte
e perdonò lor morte:
or hanno lui e soie membre conquise.
[31] Ahimè (lasso), ora [Firenze] non è un Leone, poiché (ch’eo) lo vedo (li veo – veo forma siciliana) che le sono state strappate (tratto) le unghie (onghie), e (e…e…e - polisindeto) i denti e la forza (lo valore), e la sua nobile stirpe (’l gran lignaggio suo) è stata uccisa con dolore (mort’a dolore), ed è stata messa (mis’) con grande ingiustizia (a gran reo) in una crudele prigione (en crudel pregio[n]). E chi le (li) ha fatto ciò? [domanda retorica] Quelli che sono discesi (stratti, estratti) e nati dalla sua nobile (gentil) stirpe (schiatta) e che furono (fun) grazie a lei (per lui – riferito al leone che rappresenta Firenze) resi potenti (cresciuti) e innalzati (avanzati) sopra tutti gli altri, e collocati in posizioni di prestigio (a bono); e a causa della (per la) grande altezza dove mise i suoi concittadini (li) si insuperbirono (ennantir – provenzalismo, enantir significa innalzare) a tal punto (sì) che, la ferirono (’l piagãr = piagarono) quasi a morte; ma Dio le fece (feceli = li fece) dono della (di) guarigione ed ella (el) li perdonò (fe’ lor perdono); e ancora la (el) ferirono (refedier, dal latino re + ferire = ferire di nuovo) dopo (poi), ma [Firenze] resistette (fu forte) e risparmiò loro la vita (perdonò lor morte = non li condannò a morte): ora essi [i ghibellini] hanno conquistato (conquise) lei e i suoi domini (soie membre).
[46] Conquis’è l’alto Comun fiorentino,
e col senese in tal modo ha cangiato,
che tutta l’onta e ’l danno che dato
li ha sempre, como sa ciascun latino,
li rende, e i tolle il pro e l’onor tutto:
ché Montalcino av’abattuto a forza,
Montepulciano miso en sua forza,
e de Maremma ha la cervia e ’l frutto;
Sangimignan, Pog[g]iboniz’ e Colle
e Volterra e ’l paiese a suo tene;
e la campana, le ’nsegne e li arnesi
e li onor tutti presi
ave con ciò che seco avea di bene.
E tutto ciò li avene
per quella schiatta che più ch’altra è folle.
[46] Il prestigioso (l’alto) Comune di Firenze è stato conquistato e in tal modo si è scambiato (cangiato - provenzalismo) con il (col) senese, dato che (che) [questi] gli rende (li rende – antitesi con i tolle) tutta la vergogna (onta) e le sconfitte (danno) che [Firenze] gli (li) ha inflitto sempre, come sa ogni (ciascun) italiano (latino - sineddoche), e gli toglie (i tolle – latinismo – antitesi con li rende) tutto il potere (pro – latinismo) e l'onore: infatti (ché) [Siena] ha (av’ – forma siciliana ripetuta al v.58) abbattuto con la (a) forza [le mura di] Montalcino, sottomesso (miso en sua forza = ha ridotto in suo potere) Montepulciano, e (e…e…e - polisindeto) ha la cerva (cervia – metonimia sta per lo stemma di Cervia e indica il tributo di vassallaggio pagato a Firenze dagli Aldobrandeschi) e la rendita (’l frutto - metafora) della Maremma; [Siena] considera come suoi (a suo tene = tiene per proprio – tene è latinismo) San Gimignano, Poggibonsi, Colle [Val d'Elsa] e Volterra e il suo contado (’l paiese - latinismo); e Siena ha (ave - latinismo) preso tutto (tutti presi) la campana (campana - simbolo è la martinella, la campana di guerra), le insegne e le armi (li arnesi – metonimia) e gli arredi (li onor – metonimia), insieme a (seco - latinismo) ciò (con ciò) che c’era (avea - impersonale) di buono (di bene).
E tutto ciò gli (li – riferito a Firenze) accade (avene – latinismo) per quella parte del suo popolo [i Ghibellini] (schiatta – provenzalismo che significa famiglia) che più di ogni altra (più ch’altra) è malvagia (folle - latinismo).
[61] Foll’è chi fugge il suo prode e cher danno,
e l’onor suo fa che vergogna i torna,
e di bona libertà, ove soggiorna
a gran piacer, s’aduce a suo gran danno
sotto signoria fella e malvagia,
e suo signor fa suo grand’ enemico.
A voi che siete ora in Fiorenza dico,
che ciò ch’è divenuto, par, v’adagia;
e poi che li Alamanni in casa avete,
servite i bene, e faitevo mostrare
le spade lor, con che v’han fesso i visi,
padri e figliuoli aucisi;
e piacemi che lor dobiate dare,
perch’ebber en ciò fare
fatica assai, de vostre gran monete.
[61] È folle chi fugge il proprio vantaggio (prode – latinismo da prodest) e cerca (cher - francesismo) il danno, e fa in modo che (fa che) il suo onore (antitesi con vergogna) diventi (i torna) vergogna, e dalla (di) buona (bona) libertà, nella quale (ove) vive (soggiorna - metafora) con (a) gran piacere, si riduce (s’aduce - latinismo) con suo grave danno sotto un’autorità (signoria) traditrice (fella - provenzalismo) e malvagia, e fa del suo maggior nemico (suo grand’ enemico - latinismo) il suo signore (signor - antitesi con enemico).
A voi che siete ora in Firenze (siete ora in Fiorenza – si rivolge ai ghibellini) dico, che ciò che è successo (ch’è divenuto), a quanto sembra (par), vi piace (v’adagia - provenzalismo); e dato che (poi che) avete in casa i tedeschi (li Alamanni), serviteli (servite i) bene e fatevi (faitevo) mostrare le loro spade, con cui (con che) vi hanno ferito (v’han fesso – latinismo) il viso, [e] ucciso (aucisi) padri e figli; e mi fa piacere (piacemi) che dobbiate dare loro (lor dobiate dare) molto del vostro denaro (de vostre gran monete), poiché fecero molta fatica nel fare ciò (ebber en ciò fare fatica assai).
[76] Monete mante e gran gioi’ presentate
ai Conti e a li Uberti e alli altri tutti
ch’a tanto grande onor v’hano condutti,
che miso v’hano Sena in podestate;
Pistoia e Colle e Volterra fanno ora
guardar vostre castella a loro spese;
e ’l Conte Rosso ha Maremma e ’l paiese,
Montalcin sta sigur senza le mura;
de Ripafratta temor ha ’l pisano,
e ’l perogin che ’l lago no i tolliate,
e Roma vol con voi far compagnia.
Onor e segnoria
adunque par e che ben tutto abbiate:
ciò che desïavate
potete far, cioè re del toscano.
[76] Monete in abbondanza (mante) e (e…e…e - polisindeto) molti gioielli (gran gioi’) offrite (presentate) ai Conti (antonomasia – il solo titolo nobiliare designa i Conti Guidi) e agli (a li) Uberti e a tutti gli altri [Ghibellini] che vi hanno condotto (condutti - latinismo) a un tale onore, che hanno (v’hano) messo (miso - latinismo) Siena in vostro potere (in podestate - latinismo); Pistoia e (e…e…e - polisindeto) Colle Val d'Elsa e Volterra ora fanno sorvegliare (guardar) le vostre fortezze (castella) a loro spese; e il Conte Aldobrandino (’l Conte Rosso) ha il territorio della Maremma (Maremma e ’l paiese), Montalcino sta al sicuro (sta sigur) senza le mura; i Pisani (’l pisano – sineddoche - singolare al posto del plurale) hanno timore (temor - latinismo) per (de) Ripafratta e i Perugini (’l perogin – sineddoche - singolare al posto del plurale) [temono] che togliate loro (no i = non gli) il lago [Trasimeno], e Roma vuole (vol) allearsi (far compagnia) con voi.
Sembra dunque che abbiate onore e potere (segnoria), e ogni altro bene (ben tutto): potete fare ciò che desideravate (desïavate), ovvero farvi signori di tutti i toscani (re del toscano – sineddoche - singolare al posto del plurale).
[91] Baron lombardi e romani e pugliesi
e toschi e romagnuoli e marchigiani,
Fiorenza, fior che sempre rinovella,
a sua corte v’apella,
che fare vol de sé rei dei Toscani,
dapoi che li Alamani
ave conquisi per forza e i Senesi.
[91] Signori (Baron) del Nord (lombardi) e (e…e…e - polisindeto) romani e del Sud (pugliesi) e toscani (toschi) e romagnoli e marchigiani, Firenze, fiore (fior – metafora e metonimia) che sempre rinasce (rinovella), vi chiama (v’apella - latinismo) alla sua corte, poiché (che) vuole proclamarsi (fare vol de sé) regina (rei - re) dei Toscani, dal momento che (dapoi che) ha (ave latinismo) conquistato (conquisi) con la (per) forza i Tedeschi (li Alamani) e i Senesi.
Tematica
Il tema del componimento Ahi lasso, or è stagion de doler tanto è incentrato sulla sconfitta subita dai fiorentini guelfi il 4 settembre 1260 a Montaperti, battuti dagli esuli ghibellini di Siena alleati con le truppe tedesche di Manfredi. Sconfitta vista come un vero e proprio disastro che toglie ai fiorentini la loro libertà.
Riassunto del testo della poesia
- Prima strofa: il poeta esprime il dolore per la situazione di Firenze dopo la sconfitta di Montaperti e si meraviglia che, chiunque ami la giustizia, possa sopravvivere ad una così grande sventura. La potente Firenze, erede della grandezza romana (l’onorata antica tradizione romana, v.6 - secondo alcune leggende, Firenze poteva vantare origini romane), perirà miseramente se non si cerca subito di restituirle il suo splendore;
- Seconda strofa: vi è il ricordo della passata grandezza di Firenze che si estendeva ampiamente per regioni e province e ciò, afferma Guittone, le era dovuto perché essa non si espandeva per un proprio vantaggio ma per assicurare la pace e la giustizia. La città di Firenze era così potente che in ogni luogo risuonava la lode della sua gloria.
- Terza strofa: si sviluppa attorno ad una complessa ed estesa metafora di Firenze vista come un leone prostrato e reso inoffensivo e di ciò sono da condannare i ghibellini che hanno ricambiato i benefici ricevuti da Firenze, con la rovina della loro città natale.
- Quarta strofa: Guittone rievoca la vergogna subita e delinea ulteriormente il decadimento di Firenze, mostrando la soggezione politica a cui è stata ridotta la città da parte della rivale Siena. Si sono scambiate le parti e l’onta e il danno che Firenze ha sempre inferto a Siena vengono da questa rese ora a Firenze.
- Quinta strofa: Guittone accusa i ghibellini fiorentini di aver venduto Firenze ai nemici per miseri ed effimeri vantaggi personali:
- Vv.61-66 il poeta fa riferimento ai ghibellini di Firenze che hanno preferito mettere la propria città nelle mani dei soldati tedeschi di re Manfredi e dei senesi piuttosto che accettare la sua condizione di libertà e facendo ciò hanno ottenuto una vittoria che li disonora, alleandosi con i propri nemici;
- Vv.67-75 il poeta con ironia e sarcasmo feroce sottolinea che le truppe mercenarie (i tedeschi), entrate in Firenze dopo la rotta di Montaperti, sono state anche ricompensate lautamente dai capi ghibellini, per la fatica sostenuta nell’uccidere e ferire i loro stessi concittadini.
- Sesta strofa: il poeta esprime il suo sdegno attraverso il capovolgimento della realtà (con significato antifrastico), ovvero la situazione di debolezza e di sconfitta di Firenze viene presentata come positiva:
- Vv.76-79 – Il poeta afferma che i ghibellini, tra cui i Conti Guidi (così noti in Toscana che egli può designarli con il solo titolo nobiliare di Conti) e Uberti, che hanno messo Firenze nella condizione attuale, vadano lautamente premiati;
- Vv.80-81-82 – Il fatto che i castelli di Pistoia, Colle e Volterra siano staticonquistati dal nemico solleva Firenze dalle spese per il loro mantenimento, ora è l’avversario che deve custodirle a proprie spese e quindi gratis per i fiorentini. Anche qui è chiaro il significato antifrastico;
- V.83-90 – Ironia massima in questi versi dove il poeta cita come se fossero vere situazioni che non son tali:
- La maremma è in mano al Conte Rosso;
- Montalcino è rimasta al sicuro nonostante non abbia più le sue mura, abbattute dai senesi;
- tutti temono la potenza di Firenze (Pisa e Perugia) e Roma vuol essere sua alleata.
- Firenze può aspirare al governo di tutta la Toscana.
- La conclusione è la strofa del congedo, dove Guittone insiste con l’ironia e il sarcasmo: il poeta invita tutti i potenti d’Italia ad assistere al trionfo di Firenze sui tedeschi e senesi, qui ironicamente indicati come sconfitti (antifrasi) e a proclamare la sua supremazia sulla Toscana. L’ironia ha una vena amara ed allude alla facilità con cui chiunque in questo momento potrebbe approfittare della follia politica dei fiorentini per sottrarre a Firenze la sua potenza e le sue ricchezze.
Struttura
La struttura della canzone Ahi lasso, or è stagion de doler tanto è bipartita, divisa in due parti molto differenti per toni, immagini e contenuti:
- La prima parte (vv. 1-45) è relativa alle prime tre strofe:
- Le prime due stanze si basano su riflessioni etico-politiche espresse con i toni appassionati del compianto provenzale (planh);
- la terza rievoca la gloria passata di Firenze e le ragioni della decadenza. Il passato glorioso di Firenze viene innalzato ad una dimensione mitica attraverso il ricorso ai simboli rappresentativi della città del Fiore e del Leone.
- La seconda parte (vv. 46-97) inizia con la strofa IV e comprende anche il congedo. Riguarda la realtà storica contingente della Firenze sconfitta, documentata con dati concreti, i toni sono più descrittivi, sarcastici e lo stile solenne e sentenzioso. Lo sdegno dell’autore viene ben rappresentato attraverso il ricorso all’ironia.
Analisi del testo
Ahi lasso, or e’ stagion de doler tanto, è la lirica più famosa del gruppo delle rime etico-politiche.
Guittone si ispira all’esempio del sirventese ed anche del planh (compianto) provenzale (soprattutto nella prima strofa) e crea il genere della poesia civile italiana, di cui, successivamente, Dante e Petrarca saranno i migliori interpreti.
Le varie strofe si differenziano come tipologia:
- La prima strofa è un lamento;
- La seconda strofa esprime nostalgia e rimpianto;
- La terza strofa esprime compassione e sdegno;
- La quarta, è la strofa di biasimo nei confronti dei ghibellini;
- la quinta strofa è all’insegna dell’invettiva e dell’ironia nei confronti dei Ghibellini;
- la sesta strofa è dominata dalla feroce ironia di Guittone condotta attraverso un linguaggio antifrastico. Infatti, il testo ha un significato nettamente contrario rispetto a quello che afferma (antifrastico) e vede la realtà politica di Firenze rovesciata, degna di onore e con Siena in suo potere mentre è esattamente il contrario: Firenze è in una condizione vergognosa e sottomessa a Siena.
- La conclusione è la strofa del commiato/congedo, sembra quasi un proclama e Guittone insiste con i toni ironici e sarcastici.
Gli avvenimenti storici
Ahi lasso, or è stagion de doler tanto è una canzone (compianto-lamento) scritta, come già ricordato, in seguito ad un avvenimento storico: la sconfitta subita dai Guelfi fiorentini nella battaglia di Montaperti del 1260 per mano dei fuoriusciti ghibellini, alleati, sotto la guida di Farinata degli Uberti, con i senesi e con Manfredi, figlio di Federico II.
Guittone, fervente sostenitore della parte guelfa, rievoca i fatti dal punto di vista dei vinti, con grande passione politica, enfasi, sdegno e acredine.
Gli avvenimenti di cronaca vengono citati nella terza stanza in cui Guittone fa riferimento ai fatti storici precedenti alla sconfitta di Montaperti:
- Al verso 40 rievoca la prima sconfitta dei guelfi che avevano tentato di rioccupare Firenze nel 1248 e la loro cacciata dalla città;
- Ai vv. 41 e 42 cita la fragile pace tra guelfi e ghibellini stipulata nel 1251 dopo la morte di Federico II;
- Al v. 43 ricorda una nuova congiura ghibellina organizzata nel 1258;
- Al v. 45 racconta infine, la sconfitta di Montaperti che ha decimato le più prestigiose famiglie fiorentine.
Nella quarta stanza il riferimento storico è alle conseguenze della sconfitta, parla di Siena che a Montaperti aveva combattuto a fianco dei fuoriusciti ghibellini di Firenze e dalla vittoria aveva tratto vantaggi in termini di conquista di città e territori che erano stati di Firenze, come Montalcino che, a lungo contesa, era stata infine assegnata a Siena con il trattato del 25 novembre 1260.
Il poeta, al fine di trasferire nei lettori la propria indignazione, illustra il decadimento e l’umiliazione di Firenze anche attraverso la perdita di elementi simbolici del suo potere:
- La cervia (il tributo simbolico pagato a Firenze dai signori di Maremma, gli Aldobrandeschi);
- La campana (è la Martinella che dava in guerra gli ordini militari);
- Il carroccio;
- la bandiera.
Analisi metrica
Ahi lasso, or è stagion de doler tanto è una canzone di:
- sei strofe di quindici versi ciascuna di endecasillabi e settenari (indicati con la lettera minuscola nello schema delle rime)
- e un congedo, a chiusura del componimento.
Nelle singole strofe i versi sono distribuiti in:
- Fronte (prima parte della strofa) bipartita: 2 piedi simmetrici;
- Chiave (verso di concatenazione tra Fronte e Sirma);
- Sirma (seconda parte della strofa): 2 volte in terzine.
Tutte le strofe, tolta l’ultima, il congedo, sono collegate tra loro attraverso capfinidas (ripresa nel verso del termine che chiude la strofa che precede):
- la prima strofa termina con il termine altezza e la seconda inizia con altezza.
- La seconda strofa finisce con leone e la terza inizia con leone.
- La terza strofa finisce con conquise e la quarta inizia con conquis’è.
- La quinta strofa finisce con folle e la sesta inizia con foll’è.
- La sesta strofa finisce con monete e la settima inizia con monete.
Linguaggio solenne, ricercato nella retorica, difficile e alto stilisticamente, attraverso cui Guittone esprime la sua passione, il profondo sdegno e il forte risentimento morale.
Numerosi gli artifici retorici e l’uso di sinonimi (per es.: corrotto e pianto, v.4; grandezza e ‘l pregio, vv.9-10; valor e ‘l poter, v. 11; giustizi’ e poso, v.26; ecc.).
Diffuso l’impiego di ironia e sarcasmo, attraverso un linguaggio antifrastico, sui quali si strutturano le ultime due strofe e il congedo.
Rime
Le rime seguono lo schema: ABBA CDDC EFGgFfE . Il congedo ripete la sirma (EFGgFfE).
I settenari (indicati con la lettera minuscola nello schema delle rime) sono in rima baciata con l’endecasillabo che li precede (es.: dia/desvia, vv.12-11 - audito/sofrito, vv.14-13; amoroso/poso, vv.27-26 – canto/tanto, vv.29-28; ecc.).
Si distinguono inoltre:
- Rime ricche (nella terminazione identità dei fonemi che precedono la vocale accentata), numerose soprattutto nella parte iniziale della canzone: ragione/guerigione, vv.2-3; valore/dolore vv.32-33; dono/perdono, vv.41-42; fiorentino/latino, vv.46 e 49;
- Rime equivoche (riferite a vocaboli identici ma che hanno significati diversi): tanto/tanto, vv.25 e 28; a morte/morte, vv.40 e 44; forza/forza, vv.51 e 52; danno/danno, vv.61 e 64;
- Rime univoche (cioè con parole-rima identiche), oltre alle equivoche ci sono: tanto, vv. 1, 25 e 28; ragione / a ragione, vv.2 e 24; valore, vv. 19 e 32;
- Rime siciliane/imperfette: ora/mura, vv.80 e 83.
La ricchezza di rime, non solo all’interno della medesima strofa ma talvolta tra diverse strofe, dà coesione all’intero componimento e spicco ad alcuni termini-chiave.
Figure retoriche
Approfondimento di alcune figure retoriche:
- ca morto no l’ha già corrotto e pianto, v.4
- fu mai tanto crudel dannaggio audito, v.13
- …hailo…, v.14
- Altezza tanta êlla sfiorata Fiore / fo, mentre ver’ se stessa era leale, vv.16-17
- e sembrava che far volesse impero, v.21
- …e leggero / li era…, vv.22-23
- …folli…, v.27
- E ciò li ha fatto chi…, v.35
- Quelli che sono / de la schiatta gentil sua stratti e nati, vv.35-36
- ma Deo di guerigion feceli dono, v.41
- Conquis’è l’alto Comun fiorentino, v.46
- Foll’è chi fugge il suo prode e cher danno, / e l’onor suo fa che vergogna i torna, vv.61-62
- A voi che siete ora in Fiorenza dico, v.67
- …li Alamanni in casa avete, / servite i bene, vv.69-70
- padri e figliuoli aucisi, v.72
- …che lor dobiate dare, v.73
- perch’ebber en ciò fare / fatica assai, vv.74-75
- ch’a tanto grande onor v’hano condutti, v.78
- che miso v’hano Sena in podestate, v.79
- de Ripafratta temor ha ’l pisano, v.84
- adunque par e che ben tutto abbiate, v.88
- ciò che desïavate / potete far…, vv.89-90
- a sua corte v’apella, v.94
- che fare vol de sé rei dei Toscani, v.95
- dapoi che li Alamani / ave conquisi per forza e i Senesi, vv.95-96
- deritto pèra e torto entr i ’n altezza, v.15
- Altezza tanta êlla sfiorata Fiore, v.16
- li rende, e i tolle…, v.50
- e l’onor suo fa che vergogna i torna, v.62
- …tutta l’onta e ’l danno… /… li rende, e i tolle il pro e l’onor tutto, vv.48 e 50:
- complemento oggetto (l’onta e ’l danno) + predicato verbale (li rende)
- predicato verbale (i tolle) + complemento oggetto (il pro e l’onor)
Questo chiasmo include un altro chiasmo anche con gli aggettivi indefiniti tutta e tutto:
- aggettivo indefinito (tutta) + complemento oggetto (l’onta e ’l danno)
- complemento oggetto (il pro e l’onor) + aggettivo indefinito (tutto).
- Foll’è chi fugge il suo prode e cher danno, / e l’onor suo fa che vergogna i torna, vv.61-62:
- predicati verbali (fugge e cher) + complementi oggetto (suo prode e danno)
- complementi oggetto (onor e vergogna) + predicati verbali (fa e torna)
- …s’aduce a suo gran danno /…e suo signor fa…, vv.64-66:
- predicato verbale (s’aduce) + complemento oggetto (a suo gran danno)
- complemento oggetto (suo signor) + predicato verbale (fa)
- Monete mante e gran gioi’…, v.75:
- nome (monete) + aggettivo (mante)
- aggettivo (gran) + nome (gioi’)
- ca morto no l’ha già corrotto e pianto, v.4
- grandezza / e ’l pregio quasi è già tutto perito, vv.9-100
- fu mai tanto crudel dannaggio audito, v.13
- ritenea modo imperïale, v.18
- che ’l piagãr quasi a morte, v.40
- …or è stagion de dolor…, v.1 – stagione per dire che è il momento del dolore;
- …l’alta Fior…, v. 5 – fiore che ha le qualità della bellezza, della grazia, di gioia, ecc. indica Firenze. Metafora ripresa anche nei versi successivi: vedi v.16 e v.93;
- …Leone…, v.30 e seguenti – si riferisce alla grandezza, al coraggio di un animale per definire Firenze;
- …l’ frutto…, v.53 – si riferisce alla ricchezza;
- …l’alta Fior…, v.5 – Fior sta per giglio, quindi il simbolo di Firenze è utilizzato per indicare tutta la città. Notare che l’aggettivo abbinato (alta) è al femminile perché riferito a città e non a fior. Metonimia ripresa anche nei versi successivi: vedi v.16 e v.93;
- …Leone…, v.30 – come per Fior Guittone utilizza un simbolo, in questo caso il simbolo del leone, per indicare Firenze;
- …ha la cervia…, v. 53 – la cerva era il simbolo del tributo di vassallaggio pagato a Firenze dagli Aldobrandeschi, signori della contea di Santafiora in Maremma;
- …li arnesi, v. 56 – indica gli utensili in ferro, quindi fa riferimento al materiale di cui è composto per indicare l’oggetto;
- …li onor…, v.57 – fa riferimento ad un concetto astratto per indicare una cosa concreta;
- entr i ’n altezza, v.15;
- Quelli che sono / de la schiatta gentil sua stratti e nati, / che fun per lui cresciuti e avanzati / sovra tutti altri, e collocati a bono, vv.35/38 – lunga perifrasi per designare i ghibellini;
- vv.32, 54-55, 56-57, 77, 80, 91-92.