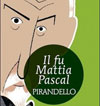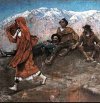La datazione della poesia Il passero solitario è incerta. Il poeta già negli anni intorno al 1819-20 rifletteva sull'idea di mettere in poesia la tematica contenuta ne Il passero solitario ma solo dopo più di un decennio (tra il 1829 e il 1831) è arrivato a realizzare la stesura vera e propria.
TESTO
PARAFRASI
[1]
D'in su la vetta della torre antica,
Passero solitario, alla campagna
Cantando vai finché non more il giorno;
Ed erra l'armonia per questa valle.
Primavera dintorno
Brilla nell'aria, e per li campi esulta,
Sì ch'a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
Gli altri augelli contenti, a gara insieme
Per lo libero ciel fan mille giri,
Pur festeggiando il lor tempo migliore:
Tu pensoso in disparte il tutto miri;
Non compagni, non voli,
Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi;
Canti, e così trapassi
Dell'anno e di tua vita il più bel fiore.
[1] Dalla cima (D'in su la vetta) dell’antica torre (torre antica - il campanile di Sant'Agostino in Recanati), o passero solitario (apostrofe), vai cantando (Cantando vai – presente durativo = continui a cantare) verso i campi finché non viene sera (non more il giorno - metafora); e la melodia si diffonde (erra l’armonia) in questa valle. Tutto intorno (dintorno) la primavera (personificazione) risplende (brilla) e si diffonde (esulta) per i campi (chiasmo) così che a guardarla (mirarla) si prova un senso di tenerezza (intenerisce il core).
Senti (Odi) le pecore (greggi) belare e le mucche (armenti) muggire (chiasmo); gli altri uccelli (augelli - arcaismo) contenti (rima interna con armenti), volano inseguendosi (a gara insieme) nel cielo sereno (per lo libero ciel), fanno mille voli (giri) anch'essi (pur) festeggiando la primavera (il lor tempo migliore – si riferisce alla primavera della loro vita cioè alla gioventù): tu [o passero] stai in disparte e pensoso (pensoso: personificazione, il poeta attribuisce atteggiamenti umani al passero) osservi tutto ciò (il tutto miri); non hai compagni, non voli, non ti importa (non ti cal) dell'allegria, eviti (schivi) i divertimenti (spassi); canti, e così trascorri (trapassi) il più bel periodo (il più bel fiore - metafora) dell’anno [la primavera] e della vita [la giovinezza].
[17] Oimè, quanto somiglia
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
Della novella età dolce famiglia,
E te german di giovinezza, amore,
Sospiro acerbo de' provetti giorni,
Non curo, io non so come; anzi da loro
Quasi fuggo lontano;
Quasi romito, e strano
Al mio loco natio,
Passo del viver mio la primavera.
Questo giorno ch'omai cede alla sera,
Festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla,
Odi spesso un tonar di ferree canne,
Che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
La gioventù del loco
Lascia le case, e per le vie si spande;
E mira ed è mirata, e in cor s'allegra.
Io solitario in questa
Rimota parte alla campagna uscendo,
Ogni diletto e gioco
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo
Steso nell'aria aprica
Mi fere il Sol che tra lontani monti,
Dopo il giorno sereno,
Cadendo si dilegua, e par che dica
Che la beata gioventù vien meno.
[17] Povero me (oimè - esprime tristezza nel constatare la somiglianza), come assomiglia il mio al tuo modo di vivere (al tuo costume – parallelismo con il passero)! Non tengo in alcun conto (Non curo) il divertimento (sollazzo – arcaismo) e le risate (riso), [che sono] dolce compagnia (famiglia – latinismo, sta per compagnia) della giovinezza (novella età - arcaismo, sta per giovinezza), [non tengo in alcun conto] nemmeno te, o amore (apostrofe), fratello (german – arcaismo) della giovinezza, doloroso rimpianto (sospiro acerbo) dell'età matura (provetti giorni – latinismo, sta per i giorni ormai andati troppo avanti). Non so perché mi comporto così (io non so come), anzi scappo lontano da loro, quasi lontano (romito) ed estraneo (strano), al mio paese natale (Al mio loco natio – Recanati), trascorro la giovinezza della vita (del viver mio la primavera - metafora). Questo giorno che ormai (omai) lascia il posto (cede) alla sera viene solitamente (si costuma) festeggiato nel nostro borgo. Senti (odi) nel cielo sereno (lo sereno) il suono di una campana (un suon di squilla - allitterazione ), e senti spesso il rumore sordo (un tonar) dei colpi dei fucili (ferree canne – allitterazione – colpi sparati in segno di festa) che risuonano (rimbomba - onomatopea) lontano di casolare in casolare (villa – v. 31 allitterazione). I giovani (la gioventù - metonimia) del paese tutti (tutta - accresce il senso dell'esclusione) vestiti a festa lasciano le case e si riversano per le vie, guardano e sono ammirati (mira ed è mirata – scambio di sguardi tra i giovani) e il cuore si rallegra. Io, solitario (io solitario - riporta al Tu pensoso del v.12 riferito al passero), andando nella campagna verso questo luogo remoto (Rimota parte), rimando (indugio) ad altro momento (in altro tempo) ogni piacere e ogni divertimento (diletto e gioco) e intanto il mio sguardo (guardo) che corre lontano nell’aria limpida (aprica), viene colpito dal sole (Mi fere il Sol) che, dopo una giornata serena, calando scompare (cadendo si dilegua) tra i monti lontani, e sembra avvertirmi (par che dica) che la gioventù si dilegua anch’essa (vien meno) [metafora].
[45]Tu, solingo augellin, venuto a sera
Del viver che daranno a te le stelle,
Certo del tuo costume
Non ti dorrai; che di natura è frutto
Ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
La detestata soglia
Evitar non impetro,
Quando muti questi occhi all'altrui core,
E lor fia vòto il mondo, e il dì futuro
Del dì presente più noioso e tetro,
Che parrà di tal voglia?
Che di quest'anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
Ma sconsolato, volgerommi indietro.
[45] Tu uccellino solitario (solingo augellin - apostrofe) giunto alla fine della vita (metafora - sera = fine della vita) che il destino (stelle) ti avrà assegnato, certamente del tuo modo di vivere (costume - sottolineato già al v.18) non ti lamenterai (non ti dorrai), poiché ogni vostro desiderio, anche la cosa più strana (ogni vostra vaghezza) è un fatto naturale (di natura è frutto). A me (in opposizione al tu del v.45) se non riesco a ottenere di evitare (evitar non impetro) la orribile vecchiaia (di vecchiezza la detestata soglia - metafora), quando i miei occhi non ispireranno più nulla (muti) al cuore degli altri uomini e il mondo intero sarà per loro privo di ogni fascino (lor fia voto il mondo), e il futuro (dì futuro) sembrerà loro ancora più noioso e cupo del presente (dì presente). Che cosa penserò (parrà) di tale scelta (voglia - riferito alla voglia del poeta di solitudine)? Che cosa di questi anni giovanili vissuti?, che cosa di me stesso (che/che/che – anafora). Mi pentirò (pentirommi) e sovente mi volgerò indietro senza speranza di conforto (sconsolato).
Analisi del testo della poesia
Il passero solitario è una poesia autobiografica che porta in primo piano l’io del poeta. Composta tra il 1832 e il 1835 ha per tema principale la solitudine e l’isolamento esistenziale che portano il poeta al rimpianto tardivo per una giovinezza non vissuta né goduta.
Parallelismi – una serie di parallelismi sottolinea l’identità del comportamento del passero e del poeta:
- Il passero viene descritto: solitario (v.2), pensoso (v.12), solingo (v.45)
- il poeta viene descritto: solitario (v.36), romito, e strano / al mio loco natio (vv.24-25)
Il canto è diviso in tre strofe in cui le figure del passero e del poeta sono accomunate dalla necessità di solitudine e divise dal diverso destino che li attende:
- Il passero arriverà alla fine della propria vita senza rimpianti perché per lui il fatto di vivere in solitudine è una scelta naturale;
- Il poeta invece arrivato alla vecchiaia non potrà che rimpiangere ciò che non ha vissuto in gioventù e pentirsi quando ormai sarà troppo tardi.
Il poeta fa risaltare la solitudine e la tristezza del suo vivere chiuso in se stesso contrapponendolo ad una ambientazione festosa. I versi idillico-descrittivi rievocano un gioioso paesaggio primaverile in cui spicca la malinconia che pervade il poeta.
Il riferimento alla primavera (v.5, 16, 26) ha chiara valenza metaforica, come stagione della vita riporta alla giovinezza, così come il tramonto richiamato in alcuni versi (v.3, 27, 41/44 e 45) riporta alla vecchiaia.
La poesia è all’origine di quel pessimismo cosmico che pervarrà tante liriche di Leopardi.
Struttura
La struttura del testo si basa sulla similitudine tra il passero e il poeta.
L’analogia tra il passero ed il poeta è evidenziata nelle prime due strofe mentre la diversità è sottolineata nella terza:
- La prima strofa (vv.1 - 15) è incentrata sul passero e ne descrive il comportamento. Nella natura in festa (periodo primaverile) si inserisce, in contrasto, l’isolamento del passero che non ha bisogno di compagnia ma solo di cantare ed il suo canto si diffonde ovunque.
- La seconda strofa (vv.16 - 44) è incentrata sul poeta ed è costruita in modo perfettamente simmetrico a quella precedente, introducendo il parallelismo tra la vita del passero e quella di Leopardi. Descrive la solitudine del poeta anche in questo caso, come per la strofa dedicata al passero, inserita nella descrizione dei suoi compaesani e coetanei partecipi del giorno di festa.
- La terza strofa (vv.45 - 49) è incentrata sia sul passero che sul poeta che si dividono in modo pressoché identico i versi della strofa. Leopardi dopo aver descritto nelle strofe precedenti ciò che li accomuna, adesso sottolinea la differenza che contraddistingue i due soggetti. Il passero che ha vissuto in solitudine in base alle leggi della natura, quindi inconsapevole delle sue scelte, non avrà rimpianti (non ti dorrai) mentre il poeta che può scegliere come vivere, in quanto dotato di ragione, non può che arrivare a pentirsi (Ahi, pentirommi) per aver sprecato la gioventù nella solitudine. La sconsolata ammissione di sconfitta viene sottolineata dal poeta con la triplice interrogativa retorica degli ultimi versi (che…? che…? che…?).
Confronto con la poesia A Silvia
Il componimento richiama, per struttura e argomentazione, la poesia A Silvia, liriche entrambe basate sul rimpianto e il rammarico ma con nessi temporali differenti:
- In A Silvia sono in relazione passato e presente;
- Ne Il passero solitario sono in relazione presente e futuro, anche se il presente considerato nella prospettiva del domani viene visto come passato.
Le due liriche si differenziano anche nella conclusione che non riguarda, in questo caso, la vanità delle illusioni giovanili, come in A Silvia, ma il rimpianto di non averle vissute fino in fondo.
Analisi metrica
Con Leopardi la poesia concepita come canto rifiuta le forme chiuse del sonetto, della ballata, del madrigale, a favore di una forma aperta basata su una libera alternanza di endecasillabi e settenari.
Tre strofe di lunghezza diversa in cui la rima non è più inquadrata in un rigido schema metrico. L’ampio uso di enjambement dilata il ritmo e dà particolare risalto alle immagini.
Dal punto di vista linguistico la poesia è impreziosita da latinismi (famiglia, provetti giorni) e arcaismi (sollazzo, novella età, german) ma il poeta utilizza anche, soprattutto nelle sequenze descrittive, parole del mondo quotidiano. Il linguaggio appare dolce e suggestivo nelle descrizioni paesaggistiche mentre adotta espressioni aspre nei versi dedicati alla vecchiaia, connotati da termini negativi (detestata, muti, noioso, tetro ecc.).
La descrizione della festa paesana è basata su notazioni acustiche (Odi…un suon di squilla…Odi un tonar…) che accentuano la tendenza melodica del componimento.
Il ritmo dei versi segue l’andamento ora festoso di alcuni passaggi, ora malinconico di altri. Ciò è riscontrabile anche la scelta dei verbi:
- Dinamici e vitali nelle parti relative alla primavera/giovinezza: es.: v.3 cantando vai; v.6 brilla…esulta; v.7 intenerisce; v.8 belar…muggire; v.11 festeggiando; v.28 festeggiar; v.35 s’allegra;
- Spenti o addolorati quando riferiti allo stile di vita del poeta e al suo rimpianto: es.: v.14 schivi; v.23 fuggo; v.27 cede; v.39 indugio; v.43 cadendo si dilegua; v.44 vien meno; v.58 pentirommi; v.59 volgerommi.
Enjambements: vv. 1-2; vv. 5-6; vv. 9-10; vv. 15-16; vv. 17-18; vv. 36-37; vv. 38-39; vv. 39-40; vv. 48-49; vv. 50-51; vv. 51-52.
Figure retoriche
Approfondimento di alcune figure reoriche:
Anastrofi– al v. 16: dell’anno e di tua vita il più bel fiore; v. 26: del viver mio la primavera; v. 48: di natura è frutto; vv. 50-51: di vecchiezza / la detestata soglia.
Anafore:
- vv.13 e 14: Non compagni, non voli,/Non ti cal d'allegria;
- vv. 23 e 24: quasi fuggo lontano / quasi romito e strano;
- vv. 29 e 30: odi per lo sereno…/ odi spesso un tonar.
Allitterazioni– varie allitterazioni sono presenti in tutti e tre i versi, a volte con la funzione di riprodurre suoni e rumori, per esempio:
- Un suon di squilla – riproduce il suono squillante delle campane;
- Un tonar di ferree canne – riproduce il suono sordo dei colpi di fucile;
- Che rimbomba lontan di villa in villa – riproduce l’eco del rumore degli spari che si perdono nell’aria.
Metafora - ai vv. 39/44: la descrizione del tramonto del sole e della fine della giornata sono metafora della fine della gioventù e della vita.
Chiasmo
- al v. 6: Brilla nell'aria, e per li campi esulta (verbo-sostantivo – sostantivo-verbo).
- al v. 8: Odi greggi belar, muggire armenti (sostantivo-verbo – verbo-sostantivo).