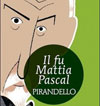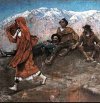“Novembre” è una delle liriche più famose di Giovanni Pascoli, tratta dalla raccolta Myricae, sezione In campagna (XVIII), è stata pubblicata nel 1891.
In origine doveva intitolarsi San Martino, come l’omonima poesia di Carducci, infatti lo spunto è dato dall’estate di San Martino, il periodo che comprende quei giorni di Novembre in cui, dopo il primo freddo, la temperatura torna ad essere mite, dando l’illusione di essere in primavera.
TESTO
PARAFRASI
[1]
Gemmea l'aria , il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l'odorino amaro
senti nel cuore...
[1] L’aria è come una gemma (gemmea, deriva dall'aggettivo latino gemmeus ma viene qui usato come verbo - Gemmea l’aria è metafora: indica che l'aria ha le caratteristiche di purezza e limpidezza della gemma e sinestesia tatto+vista), il sole [è] così luminoso (chiaro) che ti spinge a (tu generico, impersonale) cercare (ricerchi) gli albicocchi in fiore e nel cuore senti l’odorino amarognolo (odorino amaro – sinestesia – odorato+gusto) del biancospino (prunalbo) [non lo percepisci realmente con i sensi ma attraverso il ricordo evocato dal cuore]…
[5] Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.
[5] Ma (Ma antitetico che rompe l’illusione e riporta alla realtà autunnale) il biancospino (pruno) è secco e le piante spoglie (stecchite) tracciano nel cielo sereno (segnano il sereno) segni (trame) neri (nere), e il cielo è deserto (vuoto il cielo - privo di voli d’uccelli, contrariamente a quanto accade in primavera), e il terreno quando il piede lo calpesta (piè sonante ipallage) sembra vuoto (cavo – perché è reso compatto e duro dal gelo).
[9] Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. E' l'estate
fredda, dei morti.
[9] Intorno [c’è] silenzio, soltanto per il soffiare del vento (ventate), senti lontano un cadere di foglie fragili (di foglie un cader fragile – ipallage e sinestesia vista+udito+tatto infatti vediamo e udiamo il cader delle foglie e ne percepiamo la fragilità) [provenire] dai giardini e dagli orti. È la fredda estate (estate fredda - ossimoro - sostantivo e aggettivo in contrasto) dei morti (novembre tradizionalmente è il mese del culto dei morti).
Analisi del testo della poesia:
Il poeta crede di scorgere nel paesaggio chiaro e luminoso un suggestivo scenario primaverile, ma è un’illusione. La chiarezza del sole e la trasparenza dell’aria dell’autunno novembrino suscitano suggestioni della memoria creando l’inganno di essere ancora nella stagione calda.
La poesia si scompone in due parti ben distinte:
- la prima quartina che evoca la stagione primaverile:
- la seconda e la terza quartina in cui viene rappresentata la realtà autunnale.
Un ma (verso n.5) avversativo è l’espressione che introduce lo stacco tra la prima e la seconda parte della lirica, richiamando alla realtà autunnale.
Nella poesia le sensazioni si riferiscono a tre diverse aree sensoriali:
- sensazioni visive: aria tersa e limpida (v.1), piante stecchite (v.5), cielo vuoto (v.7),
- sensazioni olfattive: odore del biancospino (v.3),
- sensazioni uditive: suono del terreno calpestato (v.7), regna il silenzio (v.9), rumore del cadere delle foglie (v.11).
Fra le sensazioni ve ne sono alcune autentiche ed altre frutto di illusione, come alla fine della prima quartina l’attesa del profumo degli alberi in fiore. Le sensazioni autentiche fanno riferimento alla stagione autunnale e quelle illusorie, alla primavera.
Il simbolismo di Pascoli si manifesta negli elementi della natura che non sono solo oggetti reali ma soprattutto simboli di uno stato d’animo del poeta e più in generale della condizione umana. Esattamente al contrario rispetto alla tecnica verista dell’impersonalità il simbolismo di Pascoli carica le descrizioni dei vari aspetti della natura di interpretazioni soggettive che riconducono al tema funebre. Attraverso il paesaggio il poeta introduce la contrapposizione vita-morte, all’apparente rinascita (l’impressione di tornare alla primavera) corrisponde la realtà della morte incombente (l’essere nella stagione autunnale). Pascoli attraverso il paesaggio ricorre ad una serie di allusioni simboliche, come per esempio:
- al verso 7: il terreno che risuona cavo suggerisce il riferimento al mondo sotterraneo, dove stanno i morti;
- al verso 11: il fragile cadere delle foglie riporta alla caducità dell’uomo;
Partendo dalla descrizione di un semplice paesaggio, Pascoli porta il lettore a riflettere sulla precarietà dell’esistenza.
Il testo è circolare, inizia con l’immagine della gemma che richiama il freddo della pietra preziosa e si conclude con la fredda estate dei morti.
Tematica:
La descrizione del paesaggio novembrino offre al poeta lo spunto per una riflessione sulla condizione di precarietà dell’uomo. Partendo dalla considerazione che ciò che appare non è ciò che è, per cui la realtà non è quella che la nostra immaginazione crea in base a impressioni e suggerimenti ingannevoli, Pascoli arriva a voler far comprendere come ogni apparenza di vita è fittizia perché dietro ad essa vi è costantemente la morte, su ogni cosa aleggia un’ineluttabile la legge di morte e dunque tutta l’esistenza dell’uomo è un inganno in cui l’incombere della fine si riveste di false apparenze.
Metro:
Tre quartine (strofe saffiche) composte da 3 endecasillabi e un quinario a rime incrociate. Schema: ABAb. Parziale assonanza in: aro/ore, ante/ate.
Nella prima strofa le vocali aperte (A, E) richiamano una sensazione di luminosità. Il verso ha una musicalità dolce.
Nelle altre due strofe le vocali chiuse (O, N) rimarcano l’atmosfera autunnale. La punteggiatura, le cesure e gli enjambement (vv. 1-2, vv. 7-8, vv.11-12) rallentano il ritmo e producono un effetto frammentato che accentua la drammaticità.
Diverse le frasi nominali utilizzate: gemmea l’aria, il sole così chiaro, vuoto il cielo e gli enjambement che contribuiscono alla musicalità della lirica che ha un ritmo complessivamente lento.
Il linguaggio è ricco di significati e simboli ed evoca impressioni. A volte il lessico si impreziosisce (gemmea) e ricorre a termini letterari (prunalbo), come è tipico nel verso carducciano.
La scelta della terminologia è estremamente precisa ed ha valenza fonosimbolica, per esempio al verso 11 l’aggettivo fragile serve ad evocare sia l’aridità delle foglie, sia la loro caducità autunnale; i termini: secco/stecchite alludono alla rigidità della morte; nere/trame/sereno rendono il vuoto di vita nel cielo in cui spiccano solo i rami scheletrici, vuoto/cavo vogliono richiamare la sensazione di aridità e di morte.
Oltre alle figure retoriche segnalate nella parafrasi vi sono anche:
- Chiasmo: Gemmea l’aria/il sole così chiaro = aggettivo – sostantivo / sostantivo – aggettivo.
- Numerosi gli iperbati: secco è il pruno (v.5), stecchite piante (v. 5), vuoto il cielo (v.7), sembra il terreno (v.8), di foglie un cader fragile (v.11).
- Allitterazioni della a, e, r nella prima strofa, della s e della r che nella seconda strofa contribuiscono a comunicare il senso di desolazione della natura,della f nei due ultimi versi che richiama il senso di fragilità della vita umana.
- Anastrofi : Gemmea l’aria (v.1); l’odorino amaro senti (vv.3/4); di nere trame segnano il sereno (v.6); di foglie un cader fragile (v.12).
-
Analogia:
- Albicocchi in fiore (v.2)= primavera, ovvero vita
- Secco è il pruno (v.5) = autunno, ovvero morte