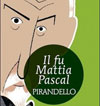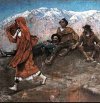Poesia del dolore
Pianto antico è una poesia autobiografica che racconta il dolore di un padre per la perdita improvvisa di uno dei suoi affetti più cari: il proprio figlio.
Il figlio di Giosuè Carducci, Dante, muore a soli tre anni, in seguito ad una epidemia di tifo nel novembre 1870. L’anno seguente, a giugno, Carducci scrive questa lirica, a cui per diversi anni non darà un titolo, scelto poi definitivamente come Pianto antico nel 1879.
TESTO
PARAFRASI
[1] L'albero a cui tendevi
la pargoletta mano ,
il verde melograno
da' bei vermigli fior,
[5] nel muto orto solingo
rinverdì tutto or ora
e giugno lo ristora
di luce e di calor.
[5] nel giardino (orto è un latinismo) silenzioso e deserto (orto muto e solingo – personificazione di orto) tutto è appena (or ora) rifiorito (rinverdì) e riscaldato dai raggi di luce e calore [del sole] di giugno.
[9] Tu fior della mia pianta
percossa e inaridita,
tu de l'inutil vita
estremo unico fior,
[13] sei ne la terra fredda,
sei ne la terra negra;
né il sol più ti rallegra
né ti risveglia amor .
Riassunto
- Prima strofa: il poeta è nel giardino di casa e racconta di quando il figlio era vivo e tendeva la sua piccola mano verso l'albero di melograno dai fiori rosso vermigli per raccoglierne i frutti.
- Seconda strofa: nel giardino ora silenzioso e deserto tutto sta rifiorendo e rinascendo alla luce e al sole di giugno.
- Terza strofa: ma il poeta è come una pianta sterile, che è percossa e senza acqua perché ormai il suo unico fiore, il figlioletto, è morto.
- Quarta strofa: il bambino si trova ormai sotto la terra scura e fredda dove il sole non può più rallegrarlo e tutto l’amore del poeta non può riportarlo in vita.
Titolo
Con la scelta del titolo Pianto antico, Carducci vuole, accostando l'aggettivo antico a pianto, sottolineare il valore universale ed eterno del dolore (pianto) provato da tutti i genitori, di ogni tempo (antico), di fronte alla morte di un figlio.
Carducci canta lo strazio antico e sempre nuovo di chi viene colpito nei suoi affetti più cari, l’universale dolore del genitore che perde il proprio figlio.
Non è la prima poesia in memoria del figlio perché Carducci appena avvenuto il tragico evento gli aveva già dedicato un sonetto: Funere mersit acerbo.
Struttura
La lirica è strutturata in due parti che si pongono in antitesi tra loro:
- Le prime due quartine incentrate sulla descrizione del giardino fatto di colori vivaci e di calore per il rifiorire della natura a primavera. È la vita vista come gioia, vitalità, energia e colore;
- Le ultime due quartine dai toni cupi e freddi della morte per la consapevolezza che la giovane vita del suo bambino e relegata per sempre nell’oscurità. È la morte come buio, freddo, silenzio e tristezza.
La contrapposizione è tra vita e morte attraverso il contrasto tra l’incessante rinascere della natura e la condizione di vuoto e aridità del poeta conseguente alla perdita del figlio.
Analisi del testo
Poesia profondamente triste ma molto composta e di grande equilibrio che esprime con semplicità e sobrietà lo strazio di un padre e un dolore senza grida.
La poesia si sviluppa sul contrasto vita-morte:
- Il poeta parte da immagini luminose e vitali di cui l’albero di melograno, simbolo di abbondanza, rappresenta la vita.
- L’immagine malinconica del muto orto solingo anticipa poi la riflessione del poeta sul rapporto tra la vita e la morte che compiutamente viene sviluppata nelle ultime due strofe e vede l’albero, ora visto come pianta metafora del poeta-padre, non più simbolo di vita, ma, tronco inaridito e percosso dal dolore.
- Nell’ultima strofa il concetto della morte come conclusione estrema e definitiva si concretizza nei toni oscuri e desolati della terra fredda e nera e reso dalle negazioni che la configurano come assenza di suoni, di luce e di calore.
Analisi metrica
Breve ode classicheggiante composta da due doppie quartine di settenari con schema: ABBC. Per ogni quartina:
- Il primo verso è libero dalla rima – corrisponde all’A dello schema;
- Il secondo e il terzo verso rimano tra di loro – corrisponde alle BB;
- Il quarto verso la rima è ripresa alla fine di ogni quartina – corrisponde alla C. I versi di ogni quarto verso sono in settenari tronchi (amor, calor, fior, amor).
Il ritmo in sintonia con le immagini descritte è un crescendo di drammaticità, risulta fluido e scorrevole nelle prime due strofe in cui vi è il concetto di rinascita della natura e asciutto, spezzato, quasi sincopato nelle ultime due incentrate sul concetto della morte.
Sono presenti 3 forti enjambements: vv.1-2, vv.7-8, vv.9-10.
Numerosi anche i latinismi, per es.: pargoletta, solingo, orto.
La scelta degli aggettivi è funzionale a creare il contrasto tra vita e morte su cui si basa l’intero componimento, così:
- gli aggettivi verde, vermigli comunicano la gioiosità della vita e la rinascita;
- mentre gli aggettivi percossa, inaridita, muto e solingo comunicano la spietatezza della vita e l'idea della morte.
Figure retoriche
Le figure retoriche in Pianto antico sono numerose:
- della r – vedi per es.: albero, pargoletta, verde, melograno, vermigli, fior, orto, rinverdì, or, ora, ristor, calor, ecc.;
- della o – vedi per es.: muto, orto, solingo, tutto, or, ora, giugno, ecc.;
- della u – vedi per es.: muto, tutto, giugno, luce, tu, ecc.;
- tu…tu, vv.9-11;
- sei…sei, vv.13-14;
- né…né, vv.15-16;
- verde melograno, v.3;
- vermigli fior, v.4;
- inutil vita, v.11;
- unico fior, v.12;
- luce / negra;
- color / fredda;
- verde melograno / pianta percossa e inaridita.
- Tu fior della mia pianta / … / tu de l'inutil vita / estremo unico fior, vv. 9/12 - sostantivo + complemento di specificazione / complemento di specificazione + sostantivo;
- né il sol più ti rallegra / né ti risveglia amor, vv.15/16 – soggetto + predicato / predicato + soggetto - costruzione chiastica che rafforza la negazione.
- pargoletta mano, v.2 - è il bambino ad essere un pargolo non la mano;
- Tu fior della mia pianta / percossa e inaridita, vv.9/10 – il fiore rappresenta il bimbo (figlio) e la pianta è il poeta (padre).
- muto orto solingo, v.5 – all’orto vengono attribuiti aggettivi propri della persona: muto e solo, che esprimono l’aspetto desolato e triste del giardino (orto) in cui non risuona più la voce del bimbo.