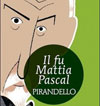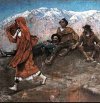Lorenzo de’ Medici poeta
Mentre comincia a prender piede il petrarchismo e a risorgere il poema epico-cavalleresco, nella seconda metà del Quattrocento va affermandosi anche un particolare tipo di poesia di argomento mitologico o amoroso. E’ una produzione letteraria completamente separata dalla realtà che non fa riferimento ad un modello di vita vera ma ad un mondo ideale di pura evasione e fantasia.
Questa poesia trova la sua realizzazione più compiuta, tra gli altri, anche nei versi di Lorenzo il Magnifico che oltre ad essere un abile politico e diplomatico è anche letterato versatile anche se poco profondo.
TESTO
PARAFRASI
[1] Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
[1] Quanto è bella la giovinezza che però fugge via di continuo, senza posa (che si fugge tuttavia)!
Chi vuole divertirsi (esser lieto) lo faccia [senza indugiare]: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro (di doman non c’è certezza).
[5] Quest’è Bacco e Arianna,
belli, e l’un dell’altro ardenti:
perché ’l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
[5] Bacco e Arianna (Quest’è Bacco e Arianna - zeugma), belli e innamorati (l’un dell’altro ardenti) l’uno dell’altro, poiché il tempo fugge e tradisce (inganna - personificazione) stanno felici sempre insieme (sempre insieme stan contenti – zeugma).
Queste ninfe (le Baccanti) e gli altri (altre genti = gli altri personaggi della mitologia che sono nel corteo) sono sempre allegri (sono allegre tuttavia).
Chi vuole divertirsi lo faccia: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro.
[13] Questi lieti satiretti,
delle ninfe innamorati,
per caverne e per boschetti
han lor posto cento agguati;
or da Bacco riscaldati
ballon, salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia
di doman non c’è certezza.
[13] Questi allegri satiretti, innamorati delle Ninfe (delle ninfe innamorati), per caverne e boschi, hanno loro teso innumerevoli insidie (cento agguati); ora riscaldati dal vino (da Bacco - metafora) ballono e saltano (ballon, salton – la desinenza in –on era molto usata dagli antichi scrittori fiorentini) sempre.
Chi vuole divertirsi lo faccia: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro.
[21] Queste ninfe anche hanno caro
da lor essere ingannate:
non può fare a Amor riparo
se non gente rozze e ingrate:
ora, insieme mescolate,
suonon, canton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
[21] Le Ninfe sono anch’esse contente (hanno caro) di essere ingannate dai Satiri: soltanto le persone rozze e sgradevoli (ingrate) possono opporsi ad Amore (non può fare a Amor riparo - iperbato): ora, mescolati insieme, suonano e cantano sempre.
Chi vuole divertirsi lo faccia: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro.
[29] Questa soma, che vien drieto
sopra l’asino, è Sileno:
così vecchio, è ebbro e lieto,
già di carne e d’anni pieno;
se non può star ritto, almeno
ride e gode tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
[29] Questo peso (soma = mole carnosa) che sta sopra l’asino è Sileno: nonostante sia così vecchio è ubriaco e felice, pieno di grasso (carne) e anni (così vecchio, è ebbro e lieto,/già di carne e d’anni pieno – chiasmo e perifrasi di carne e d’anni pieno per dire anziano e grasso); se non può stare dritto [perché è ubriaco], almeno ride e gode sempre.
Chi vuole divertirsi lo faccia: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro.
[37] Mida vien drieto a costoro:
ciò che tocca oro diventa.
E che giova aver tesoro,
s’altri poi non si contenta?
Che dolcezza vuoi che senta
chi ha sete tuttavia?
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
[37]Mida viene subito dopo costoro: ciò che tocca diventa oro. E a che serve avere ricchezze (aver tesoro) se poi uno (altri) non si accontenta [di quello che ha]?
Che piacere (dolcezza) vuoi che provi (senta) chi continua ad avere sete [a desiderare qualcosa – metafora, sete=avidità]?
Chi vuole divertirsi lo faccia: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro.
[45] Ciascun apra ben gli orecchi,
di doman nessun si paschi;
oggi siam, giovani e vecchi,
lieti ognun, femmine e maschi;
ogni tristo pensier caschi:
facciam festa tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
[45] Ognuno apra bene gli occhi, del domani [di gioie che pensa di provare in futuro] nessuno si nutra (paschi); oggi siamo, giovani e vecchi, maschi e femmine, ognuno lieto (iperbato); ogni pensiero triste sia lasciato cadere (caschi - personificazione): facciamo sempre festa.
Chi vuole divertirsi lo faccia: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro.
[53] Donne e giovinetti amanti,
viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli e canti!
Arda di dolcezza il core!
Non fatica, non dolore!
Ciò c’ha a esser, convien sia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
[53] Donne e giovani amanti, viva Bacco e viva l’Amore!
Ognuno suoni, balli e canti!
Il cuore si scaldi di dolcezza! (Arda di dolcezza il core – metafora)
Nessuno pensi alle fatiche e ai dolori!
Ciò che è destino che sia così (c’ha a esser), conviene che sia così (convien sia).
Chi vuole divertirsi lo faccia: perché non si può sapere cosa ci riserva il futuro.
Analisi del testo della poesia:
La composizione Trionfo di Bacco e Arianna, nota anche come Canzona di Bacco, viene composta da Lorenzo de’ Medici nel 1490. E’ il più celebre dei Canti carnascialeschi (carnevaleschi) di Lorenzo il Magnifico, canti che venivano cantati accompagnando, durante il carnevale, la sfilata dei carri di maschere.
Il componimento fonde la tradizione classica, evidente nei richiami mitologici, con la tradizione volgare della ballata.
La Canzona di Bacco è un inno alla giovinezza e alla spensieratezza ed un invito a godere della propria vita ogni giorno, dato che quello che succederà in futuro è imprevedibile.
Riassunto
Il poeta descrive un variopinto corteo in sfilata durante il carnevale composto da personaggi della mitologia classica, con Bacco, dio del vino e della gioia, portato in trionfo con Arianna, la sua bellissima sposa, belli e innamorati. Al seguito ci sono le ninfe ed i satiri che saltano e ballano gioiosamente. Sileno, vecchio e stanco arriva in groppa ad un asino ed anch’egli ride e partecipa al divertimento. Re Mida offre al poeta l’occasione per una riflessione sulla sete di ricchezza che distoglie dal godere a pieno la vita. La poesia si chiude con un invito a divertirsi, amarsi, gioire nel presente non pensando al domani.
I personaggi
I personaggi della Canzona di Bacco sono figure della mitologia classica:
Bacco = Dio del vino e dell’ebrezza, secondo la mitologia sposò Arianna.
Arianna = figlia di Minosse. In base alle Baccanti di Euripide, Arianna aveva aiutato, per amore, Teseo ad uccidere il Minotauro, ma era poi stata da lui abbandonata sull’isola di Nasso dove era stata trovata e consolata da Bacco.
Sileno = anziano e grasso satiro, maestro di Bacco.
Mida = Re della Frigia, bramoso di accumulare ricchezze sempre più grandi, ottenne da Bacco il potere di trasformare in oro tutto ciò che toccava, ma quando si accorse che diventava d’oro anche il cibo e le bevande, supplicò Bacco di togliergli questo potere.
Satiri = divinità minori agresti, abitanti dei boschi, dall’aspetto per metà umano per metà caprino, con zampe, corna e coda caprini.
Ninfe = divinità minori femminili che custodivano i boschi e le acque.
I personaggi sono tutte figure allegoriche, cioè rimandano a concetti astratti come la giovinezza, la bellezza, l’amore (Bacco e Arianna), la sensualità (Ninfe) la dissolutezza e il vizio (Satiri), la cupidigia e il desiderio smodato di ricchezza e di potere (Mida), la vecchiaia (Sileno).
Il tema dominante
Il testo è un invito a godere il presente con gioia considerata la brevità e caducità della vita. Ad ogni strofa il poeta ripete il concetto di derivazione epicurea con il ritornello: “Chi vuol esser lieto, sia: / di doman non c’è certezza…”.
La Canzona di Bacco è un canto allegro di esaltazione della bellezza e dell’amore ma la gioiosità della lirica è solo apparente, in realtà dietro la baldanza spensierata dei personaggi si nasconde l’inquietudine per la consapevolezza della fugacità e della precarietà della vita, che conferisce al componimento una profonda malinconia e su questa amara considerazione la poesia si conclude.
Analisi metrica:
Trionfo di Bacco e Arianna è una canzone a ballo (ballata) costituita da sette strofe di ottonari precedute da una ripresa di quattro versi. In tutte le strofe vengono ripetute, come ritornello, gli ultimi due versi della ripresa.
Schema: XYYX nella ripresa e ABABBYYX nelle sette stanze rimanenti.
La sintassi è semplice e il ritmo è agile e veloce, grazie all’utilizzo dell’ottonario e del gioco di rime, e serve ad esprimere l’esaltazione gioiosa della giovinezza a della bellezza ma anche la loro transitorietà e fugacità.
Numerosi gli enjambements: vv. 9-10, 15-16, 17-18, 21-22, 29-30, 33-34, 41-42.
Anafora nei versi 5-9-13-21-29 basata sulla ripetizione di Quest’/Questi/Queste/Questa, e allitterazioni in vari punti della poesia.
Numerose anche le anastrofi: che si fugge tuttavia (v. 2), di doman non c’è certezza (v. 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60), l’un dell’altro ardenti (v. 6), sempre insieme stan contenti (v. 8), sono allegre tuttavia (v. 10), delle ninfe innamorati (v. 14), per caverne e per boschetti han lor posto cento agguati (vv. 15-16), queste ninfe anche (v. 21), da lor essere ingannate (v. 22), suonon, canton tuttavia (v. 26), ride e gode tuttavia (v. 34), ciò che tocca oro diventa (v. 38), chi ha sete tuttavia (v. 42), di doman nessun si paschi (v. 46), ogni tristo pensier caschi (v. 49), facciam festa tuttavia (v. 50), arda di dolcezza il core (v. 54), ciò c’ha a esser, convien sia (v. 56).