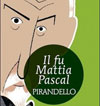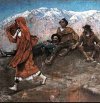La poesia Preludio di Emilio Praga costituisce la il manifesto degli Scapigliati, movimento artistico e letterario della seconda metà dell’Ottocento di cui Emilio Praga rappresenta uno dei massimi esponenti.
Attraverso l’espressione del malessere di una generazione critica verso i valori trasmessi dal Romanticismo, gli Scapigliati preparano il terreno all’avvento del Decadentismo.
TESTO
PARAFRASI
[1] Noi siamo i figli dei padri ammalati;
aquile al tempo di mutar le piume ,
svolazziammuti, attoniti, affamati,
sull'agonia di un nume.
[1] Noi [si riferisce agli Scapigliati] siamo gli eredi (figli) dei poeti romantici (padri ammalati, è la generazione del romanticismo); [siamo come] aquile nel periodo della muta (aquile al tempo di mutar le piume), svolazziamo, muti, sgomenti (attoniti), vogliosi (affamati), sul declino di una divinità (agonia di un nume). [metafora]
[5] Nebbia remota è lo splendor dell'arca,
e già all'idolo d'or torna l'umano,
e dal vertice sacro il patriarca
s'attende invano;
[5] Lo splendore dell’arca santa (arca - dove Mosè ripose le tavole della legge) è lontano e avvolto nella nebbia (nebbia remota) e gli uomini sono tornati a adorare il vitello d’oro (idolo d’or – il denaro), e invano si attende [il ritorno] dalla cima del monte Sinai (vertice sacro) di Mosè (il patriarca – guida del popolo); [metafora]
[9] s'attende invano dalla musa bianca
che abitò venti secoli il Calvario,
e invan l'esausta vergine s'abbranca
ai lembi del Sudario...
[9]Si attende invano (s'attende invano, vv.8 e 9 - anadiplosi) dalla poesia religiosa cristiana (musa bianca), che per venti secoli si ispirò ai valori cristiani (abitò...Calvario) e invano la poesia religiosa cristiana (vergine) ormai stanca (esausta), si aggrappa (s'abbranca) al lenzuolo in cui fu avvolto Cristo morto (Sudario).
[13] Casto poeta che l 'Italia adora,
vegliardo in sante visioni assorto,
tu puoi morir!... Degli antecristi è l'ora!
Cristo è rimorto!
[13]Manzoni (casto poeta – apostrofe – definito casto perché espressione della poesia cristiana) che l’Italia adora, autorevole (vegliardo, l'età avanzata, quasi ottantenne, gli conferisce autorevolezza) e profondamente intento nei suoi religiosi pensieri (in sante visioni assorto), puoi anche morire!... è giunta l’ora dei poeti ribelli scapigliati (degli antecristi è l’ora, allude ai nuovi scrittori avversari del cristianesimo, atei)! Cristo è morto per la seconda volta! (Cristo è rimorto! – ucciso dalla religione del profitto)[metafora]
[17] O nemico lettor, canto la Noia,
l'eredità del dubbio e dell'ignoto,
il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia,
il tuo cielo, e il tuo loto!
[17] O nemico lettore (apostrofe – il lettore è definito nemico perchè secondo l'autore appartiene al ceto borghese ostile alla poesia degli Scapigliati), io canto la Noia, prodotto del dubbio e dalla mancanza di certezze, che domina (tuo re … tuo pontefice) e che tormenta (tuo boia), [al tempo stesso] spinge verso mete elevate (cielo) e verso la degradazione (loto – significato letterale = fango – antitesi)!
[21] Canto litane di martire e d'empio;
canto gli amori dei sette peccati
che mi stanno nel cor, come in un tempio,
inginocchiati.
[21] Canto (canto…canto…canto, vv.21-22-25 - anafora) le litanie (litane) del martire (martire è colui che tende invano all’ideale) e del peccatore (di martire e d'empio empio è colui che nega ogni fede – antitesi), canto i sette peccati capitali (sette peccati - sono i peccati capitali: superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira, accidia) che stanno dentro di me (mi stanno nel cor), inginocchiati come in un tempio (similitudine).
[25] Canto le ebbrezze dei bagni d'azzurro,
e l'Ideale che annega nel fango...
Non irrider, fratello, al mio sussurro,
se qualche volta piango,
[25] Canto le ebbrezze degli slanci verso l’ideale (bagni d'azzurro – metonimia ) e l’Ideale che annega nella bassezza della realtà (fango – metonimia) …
Non disprezzarmi (irrider), fratello (riferito al lettore), per il mio sussurro (sussurro - onomatopea) se qualche volta piango,
[29] giacché più del mio pallido demone,
odio il minio e la maschera al pensiero,
giacché canto una misera canzone,
ma canto il vero!
[29] Giacché più del mio tormento interiore (pallido demone è il demone del dubbio che lo tormenta e lo porta ad una vita degradata), odio la finzione (minio, – metonimia) e l’ipocrisia (maschera – metonimia), giacché canto un infelice componimento lirico (misera canzone – perché canta la miseria della vita moderna), ma canto cose vere! (il vero)
Riassunto del testo
- Prima strofa – vv.1-4: Il Poeta parla di se stesso come parte di un gruppo di poeti [noi: gli scapigliati] eredi della generazione di poeti che definisce padri ammalati in quanto espressione del Romanticismo e di una società ormai in crisi e senza più certezze. Paragona la sua generazione a degli aquilotti, ancora incapaci di volare in maniera compiuta ma che si limitano a svolazzare sgomenti e vogliosi, verso un ideale che sta morendo.
- Seconda strofa – vv.5-8: Le certezze di salvezza di un tempo sono lontane nella nebbia, scomparse, gli uomini sono tornati ad adorare il vitello d’oro (simbolo del denaro e della legge del profitto) e invano attendono la figura salvifica di Mosè che dal monte Sinai scenda a guidare gli uomini;
- Terza strofa – vv.9-12: è inutile far riferimento ai simboli della civiltà cristiana e aggrapparsi ad essi perché la società si allontana sempre più dalla fede;
- Quarta strofa – vv.13-16: E’ giunto il momento per Alessandro Manzoni (casto poeta), anziano e di grande autorevolezza, adorato da tutti, di morire per lasciare il posto alla nuova generazione di poeti, agli antecristi, ribelli e atei (Cristo è rimorto!);
- Quinta strofa – vv.17-20: Il poeta si rivolge quindi al lettore, definito nemico perché aderisce a quei valori tradizionali dai quali gli scapigliati rifuggono ed è ostile alla loro poesia che canta invece la noia, cioè la situazione di dubbio e incertezza derivante dall’assenza di ideali e dal tramonto di ogni fede;
- Sesta strofa – vv.21-24: il poeta canta, in lamentose invocazioni, la realtà degradata della vita rappresentata dai peccati capitali;
- Settima strofa – vv.25-28: canta l’uomo che oscilla tra le più alte aspirazioni e la bassezza della realtà in cui ogni ideale inevitabilmente annega e il lettore, definito adesso fratello, perché vive la sua stessa realtà, non deve irriderlo per il suo poetare;
- Ottava strofa – vv.29-32: più del malessere esistenziale il poeta dichiara di odiare la finzione (minio) e la mistificazione (maschera) perché la poesia deve avversare ipocrisie e ornamenti per rappresentare unicamente il vero.
Dichiarazione pragrammatica
La lirica Preludio di Praga è considerata la dichiarazione programmatica della nuova poetica scapigliata in quanto ne delinea alcuni aspetti chiave:
- Il contrasto con la generazione precedente di poeti:
- i padri ammalati (v.1), ovvero la generazione dei poeti romantici
- e il casto poeta (v.15), cioè Alessandro Manzoni;
- La nascita di un nuovo gruppo di poeti (gli scapigliati), definiti antecristi (v.15) per evidenziare la loro ribellione verso il conformismo e l’affermazione di certezze basate sulla fede e sugli ideali;
- la considerazione del lettore come nemico e nello stesso tempo fratello. Nemico perché pur essendo affratellato (fratello) al poeta dalla stessa crisi di certezze e valori, data dalla medesima condizione esistenziale, la nega ipocritamente e non si ribella;
- la dichiarazione dei nuovi temi poetici:
- la Noia (v.17), in senso baudelairiano, è l’ennui o spleen, il senso di vuoto che deriva dalla mancanza di certezze;
- la propensione al dubbio e all’ignoto (v.18);
- Il divario tra Ideale (v.26) e realtà;
- il senso del peccato (vv. 21-24);
- la degradazione della vita che affoga l’Ideale nel fango (v. 26);
- la funzione della poesia è quella di rappresentare il vero e perciò diventa una sorta di coscienza critica che demistifica la realtà e la mostra in tutta la sua crudezza senza ipocrisie.
- il ruolo del poeta non è dunque quello di Vate ma è semplicemente quello di raccontare ciò che è misero (canto una misera canzone) ma è vero (ma canto il vero).
Temi principali
- Rottura con la tradizione letteraria del passato, in particolare con il Romanticismo;
- Tramonto delle certezze e degli ideali a cui fino ad allora ci si era affidati;
- Disillusione e crisi di valori;
- La Noia affermata come sentimento principale, espressione dell'angoscia esistenziale e del mal di vivere;
- Rifiuto dei valori borghesi e religiosi dominanti;
- Ribellione nei confronti della società dell’epoca considerata ipocrita e mediocre.
Titolo
Il titolo Preludio è dovuto al fatto che la lirica apre la raccolta Penombre e costituisce la chiave di lettura per le poesie che seguono.
Penombre rappresenta la raccolta di poesie di Emilio Praga più significativa in ambito scapigliato, viene pubblicata a Milano nel 1864 ed è composta, oltre che da Preludio, di 55 poesie distribuite in tre sezioni:
- Meriggi;
- Vespri;
- Mezzenotti.
Penombre è il secondo libro di versi di Emilio Praga in cui l’autore inizia a distaccarsi dal naturalismo che caratterizza la sua prima produzione poetica per affrontare tematiche più intime.
Analisi del testo della poesia
La lirica Preludio può essere suddivisa in due parti:
- la prima parte riguarda le prime quattro strofe ed è un’analisi critica.
Il poeta esprime a nome di tutti i poeti scapigliati il rifiuto dei valori e delle certezze tradizionali e afferma la crisi di ogni ideale e fede.
Vi è il ripudio dei valori, morali, religiosi ed estetici, su cui si è basata fino ad allora la tradizione letteraria, di cui Manzoni rappresenta l’esponente più autorevole.
Il poeta non viene più visto come un vate ma come un anticristo che si ribella ad un mondo ormai dominato dal Dio denaro e dal profitto, il cui compito è obbedire solo alla religione del vero, anche se sgradita e scandalosa. - la seconda parte riguarda invece le ultime quattro strofe ed è propositiva della nuova concezione dell’arte, quella dei poeti scapigliati.
Per Praga dopo la perdita delle certezze a cui ha fatto riferimento la poetica tradizionale, ora i nuovi temi poetici devono ispirarsi alla realtà nella sua crudezza e desolazione, esente da fede e ideali, e alla difficile condizione esistenziale dell’uomo.
La poesia deve essere fatta senza finzioni e abbellimenti perché deve, senza ipocrisie, cantare il vero (“canto il vero”) e quindi tutta la miseria della vita moderna.
Analisi metrica
Preludio si compone di 8 quartine (4 versi), di cui i primi 3 versi sono endecasillabi mentre l’ultimo è, alternativamente:
- un settenario nelle strofe dispari
- un quinario nelle strofe pari.
La rima è alternata con schema ABAb.
Vi è il richiamo a numerose immagini simboliche:
- arca = salvezza
- idolo d’or = ricchezza
- patriarca = Mosè
- musa bianca = poesia religiosa cristiana
- venti secoli il calvario = la storia cristiana
- sudario = simbolo della fede
Il linguaggio utilizzato da Praga è innovativo, e ricorre a immagini crude, provocatorie e allusive, non mancano comunque termini legati alla tradizione classica (nume, loto, litane, minio) e in generale il modello di riferimento rimane quello della lirica del primo Ottocento.
Figure retoriche
Approfondimento di alcune figure retoriche:
- s'attende invano / s'attende invano, vv.8-9;
- canto…canto…canto, vv.21-22-25 – la sua funzione è di mettere in evidenza il nuovo modo di poetare degli Scapigliati;
Antitesi –
le numerose antitesi vogliono sottolineare l’opposizione tra ideale e reale.
- il tuo cielo, e il tuo loto, v.19/20 – contrappone l’aspirazione ad elevarsi e la degradazione;
- martire / empio (v.21) – contrapposizione tra santo e profano, dove martire è chi invano tende all’ideale, al divino, ed empio è chi nega ogni fede;
- bagni d'azzurro / fango (vv.25-26) – contrasto tra la tensione verso l’ideale e la sua caduta nella cruda e degradata realtà;
- Casto poeta, v.13;
- O nemico lettor, v.17;
Metafora –
tutta la prima strofa si basa sulla metafora che vede gli scapigliati paragonati a delle aquile, in particolare:
- padri ammalati, v.1 – si riferisce alla generazione dei romantici considerati ammalati perché espressione di una cultura ritenuta in crisi di valori;
- aquile al tempo di mutar le piume, v.2 – nel periodo della muta perché è il periodo in cui le giovani aquile sono combattute tra il desiderio e il timore di spiccare il volo così come i giovani poeti scapigliati sono anch’essi combattuti tra il desiderio (di staccarsi dalla tradizione) ed il timore di percorrere un percorso autonomo e originale;
- svolazziam muti, attoniti, affamati, v.3 – il termine svolazziam suggerisce l'idea di un movimento incerto, senza una meta precisa ed anche gli aggettivi che seguono voglioni trasmettere un senso di smarrimento;
- sull'agonia di un nume, v.4 – si riferisce al nume della poesia o, per alcuni, può essere anche un riferimento a Manzoni, definito al v.13 casto poeta, o a Dio, in quanto atei;
tutta la seconda strofa:
- Nebbia remota è lo splendor dell'arca, / e già all'idolo d'or torna l'umano, / e dal vertice sacro il patriarca / s'attende invano, vv.5-8 – è una metafora che rifacendosi alla storia ebraica, attraverso alcuni suoi simboli, vuole evidenziare l'allontanamento dell'uomo dai valori religiosi in nome della logica economica.
L’episodio a cui Praga allude è quello biblico degli ebrei nel deserto che regrediscono al culto degli idoli, ma il ritorno di Mosè li riconduce ai valori religiosi;
- bagni d'azzurro, v.25 – è l'ideale espresso simbolicamente con il cielo/azzurro - concreto per astratto;
- fango, v.26 – rappresenta la realtà nei suoi vari aspetti, anche i più degradati, in cui ogni ideale svanisce, annega - concreto per astratto;
- minio, v.30 – sta per il belletto, il trucco quindi la finzione – concreto per l’astratto;
- maschera, v.30 – è la maschera che impedisce di osservare la realtà nella sua crudezza – concreto per l’astratto;
- sussurro, v.27.
- come in un tempio, v.23;