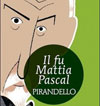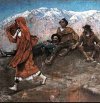Premessa
Nel 1903 Gabriele D’Annunzio compone i Madrigali dell'estate, un gruppo di 11 brevi liriche di cui fa parte anche questa poesia.
TESTO
PARAFRASI
[1] Nella belletta i giunchi hanno l’odore
delle persiche mézze e delle rose
passe, del miele guasto e della morte.
[1] Nella fanghiglia della palude (belletta – termine di origine dantesca) le canne (giunchi) hanno l'odore delle pesche (persiche – termine arcaico - pesche) sfatte (mézze – dal latino mitis = molle - persiche mézze ossimoro) e delle rose appassite (rose passe - ossimoro), del miele rancido (guasto - andato a male) e della morte.
[4] Or tutta la palude è come un fiore
lutulento che il sol d’agosto cuoce,
con non so che dolcigna afa di morte.
[4] Adesso la palude è come un fiore (similitudine) fangoso (fiore lutulento – dal latino lutum = fango – ossimoro e sinestesia) che il sole d’agosto cuoce (metafora), con un’aria stagnante (afa) e sgradevolmente dolce (dolcigna = dolciastra) [satura] di morte.
[7] Ammutisce la rana, se m’appresso.
Le bolle d’aria salgono in silenzio.
[7] La rana tace (ammutisce), se mi avvicino (m’appresso).
Le bolle d'aria salgono [dal fondo dello stagno] (il processo di putrefazione produce delle bolle di gas che salgono in superficie) silenziosamente.
Analisi del testo della poesia:
La poesia “Nella belletta” fa parte dei Madrigali dell’estate, undici brevi liriche incluse nella quarta sezione di Alcyone (Laudi), accomunate dalla tematica dell’estate che volge al termine. In questa poesia viene raccontato il momento più torrido dell’estate, quando il caldo è talmente elevato da togliere il respiro.
Tra le poesie di Gabriele D’Annunzio, “Nella belletta” si distingue per essere un testo esemplare della cultura e della poetica del Decadentismo per il senso di disfacimento, corruzione e morte che trasmette. In poche righe D’Annunzio, esponente dell’Estetismo, delinea l’ideale decadente che vede la bellezza in ogni forma di vita e di natura, persino nella sua decomposizione e nella morte.
Riassunto:
Il motivo centrale di questo componimento poetico di Gabriele D’Annunzio è la descrizione di un paesaggio segnato dal disfacimento che segue all’eccessiva maturazione estiva. Il Poeta si trova in un angolo di palude che è pervaso da un odore dolciastro di decomposizione che si alza tra il fango e i giunchi e che ricorda quello dei frutti troppo maturi (le persiche mézze) e dei fiori appassiti (le rose passe). Il paesaggio è pervaso da un’atmosfera di decadenza e putrefazione. La palude viene paragonata ad un “fiore lutulento” che, sotto il calore del sole d’agosto, esala un’aria afosa e stagnante, satura di uno sgradevole odore dolciastro. Regna il silenzio e persino le rane si ammutoliscono. Il paesaggio è caratterizzato da un’immobile staticità in cui le bolle d’aria che emergono a fior d’acqua evocano la putrefazione della morte, che segnala l’imminente metamorfosi dell’estate nella stagione autunnale.
Tema fondamentale:
Il tema è costituito, come in altre liriche di D’Annunzio, vedi ad esempio nella Sabbia del tempo, dagli effetti inevitabili dello scorrere del tempo e la consapevolezza che tutto tende a finire. Il concetto viene evidenziato nelle immagini di una natura che, per eccesso di maturazione, comincia a disfarsi e decomporsi: ormai al vertice della maturazione estiva, gli elementi naturali volgono inevitabilmente verso la putrefazione e la morte.
Il silenzio che pervade il paesaggio evoca un’immobile assenza di vita.
Dominano le sensazioni di disfacimento e di morte.
Analisi metrica:
Nella belletta è un madrigale di endecasillabi costituito da due terzine con rime (rimano tra loro i primi e i terzi versi delle terzine – odore/fiore, morte/morte) e assonanze (con la parola morte con cui terminano le terzine) e da un distico (strofa formata da una coppia di versi) conclusivo assonanzato: , ABC ADC EF.
Stile aulico ed evocativo.
Il termine “belletta” viene preso da Dante che lo utilizza nel VII canto dell’inferno per indicare il fango della palude stigia in cui sono immersi gli iracondi: “or ci attristiam ne la belletta negra” (v.124).
Il poeta utilizza una serie di immagini olfattive (vv.1-3), visive (vv.4-5), uditive (vv.7-8) che rappresentano la decomposizione e comunicano il senso di morte e di dissoluzione legato al finire dell’estate.
Gli enjambement separano gli aggettivi “passe” e “lutulento” dai sostantivi a cui si riferiscono “le rose” e “un fiore”, sottolineando con un ossimoro come i fiori appaiono diversi rispetto alla rigogliosità di quando sbocciano.
La presenza dell’io lirico diventa evidente solo alla fine (se m’appresso – v. 7) come spettatore della natura morente.
Il ritmo del testo risulta lento e cadenzato per rendere l’effetto della lenta agonia dell’estate.