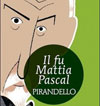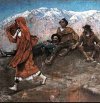Inizio della letteratura italiana
Il Cantico di frate Sole, intitolato anche Laudes creaturarum (Lodi delle creature), ha una grandissima importanza dal punto di vista storico-letterario perché è il primo testo poetico scritto in volgare italiano (volgare umbro del XIII sec.) e determina quindi l’inizio della storia della letteratura italiana.
E’ una lode e un ringraziamento a Dio, concepita come preghiera destinata ad una recitazione corale da parte dei frati francescani e dei fedeli.
San Francesco ringrazia Dio per tutte le cose dell’universo da lui create:
- siano esse positive, come il sole, l’acqua, la terra, i fiori e le stelle,
- siano esse negative, come il dolore e la morte perché rappresentano la via per la beatitudine e per la vita eterna.
Le fonti biografiche riferiscono che San Francesco compose anche la musica che doveva accompagnare la lauda, ora andata perduta.
Si pensa che Francesco d’Assisi abbia composto questo cantico uno o due anni prima della sua morte (1226).
TESTO
PARAFRASI
[1] Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
[1] [O] Altissimo, onnipotente, Dio (Signore) fonte del bene (bon), spettano a te (tue so’) tutte le lodi, le glorificazioni, gli onori e ogni (onne) benedizione.
[3] Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare
[3] A te solamente, Altissimo si addicono (se konfano) e nessun uomo (nullu homo) è degno (ène dignu) di menzionare il tuo nome (te mentovare).
[5] Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
[5] Sii lodato (Laudato sie), mio Signore, insieme con (cum) tutte le tue creature, specialmente messere (messor, signore) fratello (frate) sole, il quale (lo qual) è la luce del giorno (è iorno), e [tu] ci illumini grazie a lui (allumini noi per lui).
[8] Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significatione.
[8] E egli (ellu) è bello e raggiante (radiante) di grande splendore: è simbolo (porta significatione) di te, o Altissimo.
[10] Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
[10] Sii lodato, mio Signore per (per) [aver creato] sorella (sora) luna e le stelle: in cielo (celu) le hai create (l’ài formate) luminose (clarite – dal latino clarus), e preziose e belle.
[12] Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
[12] Sii lodato, mio Signore, per [aver creato] fratello vento e l’aria (aere) e le nuvole (nubilo) ed il sereno ed ogni tempo [atmosferico] (onne tempo) per mezzo dei quali (per lo quale) dai vita (sustentamento = la sopravvivenza) alle tue creature.
[15] Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
[15] Sii lodato, mio Signore, per [aver creato] sorella acqua (sor’aqua), che è molto utile, umile e pura (casta = pulita, limpida).
[17] Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
[17] Sii lodato, mio Signore, per [aver creato] fratello fuoco (focu), per mezzo del quale (per lo quale) illumini (ennallumini) la notte: ed esso (ello) è bello e gioioso (iocundo) e robusto (robustoso) e forte.
[20] Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
[20] Sii lodato, mio Signore, per [aver creato] sorella nostra madre terra, che ci sostenta e ci accudisce (ne sustenta et governa) e produce diversi frutti (fructi) insieme a (con) fiori variopinti (coloriti) ed erba.
[23] Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.
[23] Sii lodato, mio Signore, per [aver creato] uomini che (quelli ke) perdonano per amore tuo (per lo tuo amore) e che sopportano (sostengo) malattie (infirmitate) e sofferenze (tribulatione).
[25] Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
[25] Beati quelli che sopporteranno ciò (‘l) serenamente (in pace) perché (ka) da te Altissimo saranno premiati (sirano incoronati – cioè che saranno incoronati con la corona dei santi del Paradiso).
[27] Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccate mortali;
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.
[27] Sii lodato, mio Signore, per [aver creato] nostra sorella morte (morte corporale = morte del corpo - specifica la morte del corpo contrapponendola così alla morte dello spirito) dalla quale nessun essere (nullu homo) vivente può sfuggire (pò skappare): guai a coloro (a quelli ke) che moriranno (morrano) nel peccato (le peccate – neutro plurale) mortale; beati quelli che [la morte] troverà nelle tue santissime volontà (voluntati), poiché (ka) ad essi la seconda morte (morte secunda - quella dell’anima) non gli (‘l) farà del male.
[32] Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
[32] Lodate e benedicete il mio Signore e ringraziatelo e servitelo (serviateli – costruzione latina del congiuntivo esortativo costruito con il dativo – li = a lui) con grande umiltà (humilitate).
Riassunto e commento del testo
vv. 1-4 - i primi quattro versi affermano due concetti ricorrenti nella letteratura religiosa:
- Dio, altissimo, onnipotente e buono, è l’unico essere degno di ricevere lodi;
- Di fronte a Dio l’uomo è una nullità e non è degno neppure di nominare Dio;
vv. 5-9
- Non potendo nominare Dio direttamente vengono lodate le sue creature;
- Le lodi alle creature di Dio sono lodi per Dio stesso che è l’autore;
- Inizia quindi l’elenco delle creature lodate partendo dal sole, fonte di luce e di calore, quindi di vita e simbolo di Dio;
vv. 10-11
- Dopo il sole vengono citati gli altri corpi celesti;
vv. 12-22
- La serie prosegue elencando i quattro elementi che, secondo la fisica medievale, compongono il mondo: aria, acqua, fuoco e terra.
- Di tutte le creature elencate vengono lodate la bellezza, la bontà e la positività;
vv. 23-26 – inizia la strofa detta del perdono. Dopo aver lodato Dio per i vari aspetti della natura, piccoli e grandi, San Francesco lo loda anche per aver creato l’uomo ed il salmo procede pertanto facendo riferimento diretto all’uomo:
- Inizia da coloro che imitano il comportamento di Dio e ne seguono gli insegnamenti, come chi perdona per amore di Dio, perché in essi si riconosce la presenza di Dio;
- Prosegue con coloro che hanno la capacità di sopportare le sofferenze senza ribellarvisi, diventando così degni della beatitudine e del premio divino.
vv. 27-31 – dopo la serenità dei versi precedenti di esaltazione della vita del creato vi è un richiamo alla ineluttabilità e necessità della morte (da la quale nullu homo vivente pò skappare – v.28) con una distinzione tra la morte in grazia di Dio e morte nel peccato (che porta alla dannazione):
- Dio viene lodato per aver creato la morte del corpo (morte fisica), evento che caratterizza la condizione umana e a cui nessuno può sfuggire;
- L’uomo dotato di libero arbitrio può scegliere se meritare di appartenere all’armonia universale rispettando la legge divina o se morire nel peccato ed essere soggetto alla seconda morte, quella dell’anima, che toccherà agli uomini malvagi che verranno condannati alla dannazione eterna (all’inferno).
vv. 32-33 – nella conclusione, il poeta si ricollega ai versi di apertura (vv.2 e 4):
- si rivolge non più a Dio ma ai fedeli e li invita a lodare e servire Dio umilmente (cum grande humilitate).
Struttura del testo della poesia
Nel testo si notano due parti in contrasto:
- Vv. 1-22 – questa parte è dedicata a Dio e al suo creato, prevale il tono lirico ed una serena e gioiosa contemplazione della natura;
- Vv. 23-33 – in quest’altra parte Francesco sposta lo sguardo sull’umanità travagliata da odi e malattie, dal peccato e dalla morte, il tono diventa più drammatico e riflessivo.
Alcuni critici hanno pensato che la giustapposizione di due parti così diverse fosse dovuta al fatto che l’opera fosse stata realizzata in diversi momenti, attribuendo la stesura delle strofe finali (a partire dal verso 23) in tre tempi diversi e successivi, di cui la strofa relativa alla morte dettata appena prima della morte del Santo.
Questa ipotesi è stata esclusa dalla critica recente sulla base del fatto che tutto il Cantico ha una fondamentale unità di ispirazione che costituisce il fulcro dell’ideologia francescana:
- l’ingenua ammirazione della bellezza del creato,
- la fratellanza tra tutte le creature (animate e non)
- e l’umile e lieta accettazione di tutto ciò che proviene da Dio, compresi il dolore e la morte.
Tematica
Il Cantico è una lode a Dio ed un ringraziamento per la sua opera di creazione del mondo, sia per la bellezza e l’utilità di tutte le creature ma anche per le sofferenze, le malattie e la morte.
Il tema del salmo si sviluppa sugli argomenti consueti della ideologia e della spiritualità francescane basati sul ritorno ai valori elementari del cristianesimo, come sono affermati soprattutto nel Vangelo:
- Dio padre amoroso di tutte le sue creature;
- Armonia del creato, immagine della perfezione di Dio;
- Fratellanza universale;
- La necessità della pace;
- l’accettazione in umiltà e serenità di tutto ciò che proviene da Dio, compreso il dolore e la morte.
- la sofferenza che purifica e conduce al premio della vita eterna.
Analisi del testo della poesia
Sia per il contenuto che per la struttura in versetti il Cantico di Frate sole rimanda ai modelli liturgici dei salmi e degli inni biblici di lode a Dio.
La scelta del titolo, Cantico di frate Sole, e il fatto di iniziare l’elenco delle creature di Dio da lodare proprio con il Sole, viene spiegato dallo stesso San Francesco che ne sottolinea il valore rappresentativo (de te, Altissimo, porta significatione – v.9), in quanto, come ritenuto anche dalla simbologia religiosa medievale, simbolo di Dio stesso.
Il testo si basa sulla concezione francescana di un mondo armonioso che vede l’uomo umile e pio destinato alla felicità.
L’inserimento anche della morte tra le cose lodate rientra nell’ottica francescana che la vede come sorella (sora nostra morte corporale – v.27) che ricongiunge a Dio le creature che hanno vissuto nel bene.
In contrasto con l’atteggiamento cristiano dominante nel medioevo di disprezzo del mondo e distacco dalle cose terrene la visione di San Francesco è positiva e di gioia ed anche la morte viene vista come un dono di Dio e non come qualcosa di negativo.
E’ significativo che l’ultima parola che chiude il Cantico sia umiltà (humilitate – v.33), un termine a cui San Francesco attribuisce grande importanza in quanto fondamentale atteggiamento a cui attenersi nell’affrontare la vita e che appunto contraddistinse tutta la vita del santo.
Simbologia
San Francesco nella sua Lode richiama i principali elementi naturali: il sole, la luna e le stelle, l’aria, l’acqua, il fuoco e la terra.
In alcuni di questi elementi, elencati da San Francesco, possono essere intraviste simbologie della tradizione cristiana, per esempio:
- Il fuoco può essere un riferimento alla Pentecoste. Negli Atti degli Apostoli la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli è descritta come un’apparizione fiammeggiante;
- La notte illuminata dalla luce del fuoco richiama l’immagine dell’uomo che è illuminato dalla Rivelazione e dalla verità cristiana;
- L’acqua è un richiamo ai sacramenti del battesimo;
- La terra rappresenta anche la Madre, oltre che la sorella, perché in base alla Genesi, dalla terra è stato creato l’uomo, ed anche perché è dalla terra che l’uomo riceve, come da una madre, nutrimento.
L'uso del per
Varie interpretazioni sono state date al valore della preposizione “per”, utilizzata a partire dal v.10 e poi anche nei successivi vv.12-13-15-17-20-23-27, in base alle quali corrispondono diversi complementi:
- Secondo alcuni ha valore di complemento di mezzo in quanto lodando la luna il Santo loda Dio, per cui, per es. il verso Laudato sii… per sora luna va interpretato come: sii lodato nella luna…;
- Altri sostengono un’interpretazione causale che ad oggi è ancora la più diffusa: sii lodato per aver creato la luna...;
- Per altri ancora ha valore di complemento d’agente, a somiglianza del par francese, per cui corrisponde a da: sii lodato dalla luna…;
Analisi metrica
Il Cantico di frate sole dal punto di vista metrico presenta queste caratteristiche:
- E’ in volgare umbro;
- È composto da trentatré versi;
- I versi sono di varia lunghezza, non legati a un metro preciso;
- I versi sono ritmati in base a schemi stilistico-retorici della prosa latina medievale e della poesia biblica (vedi il salmo biblico Cantico dei Cantici)
Il ritmo conferisce sacralità al testo, è lento e ripetitivo, scandito attraverso:
- La presenza di qualche rima ma più spesso assonanze;
- Il ricorso al cursus: tecnica retorica della prosa medievale, largamente utilizzato anche nei testi liturgici, che fa riferimento ad un articolato sistema di accenti ritmici;
- Il ricorso a figure retoriche quali: l’anafora, la paronomasia, il polisindeto e l’allitterazione;
- La disposizione degli aggettivi in sequenze di tre o quattro elementi, per es: clarite et pretiose et belle (v.11); utile et humile et pretiosa et casta (v.16); ecc.;
- L’uso di coppie di termini, per es: bellu e radiante (v.8); sora luna e le stelle (v.10); sustenta et governa (v.21); ecc.;
Il testo può risultare di una certa ingenuità, ha un impianto piuttosto semplice, ma rivela anche ricercatezza formale nella scelta stilistica perché arricchito:
- con l’uso del cursus;
- con il ricorso ad assonanze;
- l’uso di aggettivi che, pur nella loro semplicità, venendo disposti a tre o quattro per volta, hanno lo scopo di far soffermare la riflessione sull’elemento a cui si riferiscono.
Alcuni aggettivi rivelano inoltre una forte e ponderata valenza, per esempio:
- utile riferito all’acqua al v.16, derivato dal verbo latino utor = in uso, rivela una connessione con la disponibilità ad essere usata.
- robustoso riferito a frate focu al v. 19, con l’aggiunta del suffisso viene arricchito di espressività.
La scelta del volgare
La lingua è il volgare umbro del XIII secolo, privo però delle forme più decisamente dialettali.
La scelta di non optare per il latino, come i faceva all’epoca, ma di referire il volgare si basa sull’esigenza di rivolgersi anche alle persone più semplici e meno istruite.
L’umbro si riconosce:
- nel finale in u tipica del suo dialetto, per esempio: Altissimu – v.1; nullu – v.4; dignu – v.4;
- ed anche in alcune forme linguistiche, tipo: sie (sta per sii); se konfano (v.3); ène (v.4 – epitesi di è, ovvero aggiunta di un fonema alla fine della parola); messor (v.6); iorno (v.7);
- per l’uso della desinenza ano per il futuro: sosterano (v.25) e sirano (v.26) –;
Inframezzate con le forme umbre il Cantico contiene anche molti termini ed espressioni derivati dal latino, come per es.:
- Onne vv.2 e 13; Aqua v.15; Multo v.16; Clarite v.11; nocte v.18; ello v.19; iocundo v.19;
- L’h iniziale di alcuni termini (es.: honore; homo);
- Ke = che (corrisponde al latino qui)
- Ka = perché (corrisponde al latino quia e al francese car)
- Proposizioni latine come ad v.3 e cum v.5, 8, ecc.
- Et come congiunzione
- I nessi cti e ti (con pronuncia zi) di alcune parole (es.: benedictione v.2; pretiosa v.16);
- Peccata (v.29) – neutro plurale usato al femminile (forma in -a) come spesso nel Duecento;
Presenti anche francesismi:
- Mentovare v.4
Figure retoriche
Approfondimento di alcune figure retoriche con qualche esempio:
- Laudato sie / Laudato si’ – all’inizio di ogni strofa ad eccezione della prima e dell’ultima (vv. 5, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 32).
- …tucte le tue – v.5 – lettere tu;
- … grande splendore – v.8 – lettere nd.
- utile/humile – v.16.
Polisindeto – la ripetizione della congiunzione et serve per dare rilievo agli aggettivi rallentando il ritmo:
- <clarite et pretiose et belle – v.11;
- utile et humile et pretiosa et casta – v.16;
- bello et iocundo et robustoso et forte – v.19.
Prosopopea/personificazione – tutti i termini relativi all’area semantica della parentela personificano il soggetto:
- Frate sole – v.6;
- Sora luna – v.10;
- Frate vento – v.12;
- Sor’acqua – v.15;
- Frate focu – v.17;
- Sora nostra madre terra – descritta anche come madre perché nutre gli uomini v.20;
- Sora nostra morte corporale – v.27.