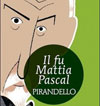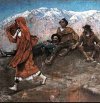TESTO
PARAFRASI
[1] Io m’aggio posto in core a Dio servire,
com’io potesse gire in paradiso,
al santo loco, c’aggio audito dire,
o’ si mantien sollazo, gioco e riso.
[1] Nel mio cuore (posto in core) ho fatto proponimento (m’aggio – l’uso del riflessivo con l’ausiliario avere è un meridiolanismo) di servire Dio, affinchè io (com’io) possa andare (gire - latinismo) in paradiso, in quel santo luogo, di cui ho (c’aggio) sentito (audito - latinismo) parlare (dire), dove si durano ininterrottamente (mantien) divertimento (sollazo - provenzalismo), gioco e riso (gioco – riso: valori tipici della società cortese, richiamati dai trovatori nei loro componimenti.) [metafora basata sul parallelo tra la vita alla corte e la vita nel paradiso]
[5]Sanza mia donna non vi voria gire,
quella c’à blonda testa e claro viso,
che sanza lei non poteria gaudere,
estando da la mia donna diviso.
[5] Ma non vi vorrei andare (non vi voria gire) senza la mia amata (donna - signora/padrona termine usato dai provenzali per definire le loro amate), colei che ha capelli biondi e il viso luminoso (blonda testa e claro viso - canoni di bellezza della donna nelle liriche cortesi – claro è un latinismo), perché senza di lei non potrei godere (gaudere - latinismo), stando separato dalla mia donna.
[9] Ma non lo dico a tale intendimento,
perch’io pecato ci volesse fare;
se non veder lo suo bel portamento
[9] Ma non lo dico con l’intenzione (intendimento - provenzalismo) di commettere peccato, ma solo per vedere il suo virtuoso contegno (bel portamento - ha valenza più morale che fisico, sta per donna di onesti costumi – portamento è provenzalismo).
[12] e lo bel viso e ’l morbido sguardare:
che·l mi teria in gran consolamento,
veggendo la mia donna in ghiora stare.
[12] e il bel viso e il dolce sguardo (morbido sguardare): perché lo riterrei (l mi teria) una gran consolazione (consolamento - provenzalismo) vedere la mia amata stare in gloria (ghiora stare - Ghiora: forma popolare del termine gloria - iperbole che eleva la donna amata in creatura angelica).
Riassunto:
Il poeta dichiara di volersi mettere al servizio di Dio per conquistare il premio eterno, il Paradiso. Il poeta immagina il Paradiso come il più piacevole dei luoghi terreni, come una sorta di prolungamento terreno della gioia e dei piaceri della vita di corte.
Egli non vuole commettere peccato, ma vedere la sua donna in Paradiso per conciliare l’amore profano per la sua amata con l’amore per Dio, l’amore sacro: la gioia che egli immagina di condividere con la sua signora (donna) scaturisce infatti dalla contemplazione della sua bellezza nella gloria del paradiso.
Analisi del testo della poesia:
In questo sonetto, come in altre poesie dei poeti della Scuola Siciliana, il personaggio fulcro è la donna.
L’omaggio alla donna, tipico della tradizione cortese, qui si arricchisce di religiosità e culmina nella divinizzazione della donna: il poeta elogia caratteristiche fisiche e morali della donna (capelli biondi e sguardo luminoso, il bel viso, l’intensità dello sguardo) e la nobiltà d’animo/il decoro (il portamento) tipiche della cultura cortese.
Il poeta mostra un atteggiamento di sudditanza e di fedeltà nei confronti della donna (senza di lei non può provare gioia), come dimostra la ripetizione del sintagma “mia donna”= “mia signora”.
A differenza di quanto avveniva nella lirica provenzale, manca qualsiasi riferimento al desiderio erotico, alla volontà di esplorare anche la dimensione fisica e carnale dell’amore. Siamo all’inizio del processo di spiritualizzazione e divinizzazione della donna (donna angelo) che verrà portato a termine dallo Stilnovo.
Analisi metrica:
Sonetto. Endecasillabi ripartiti in 4 strofe: 2 quartine con rima alternata e 2 terzine con rima incatenata. Schema di rime: ABAB, ABAB, CDC, DCD.
Rime siciliane: servire (v.1), dire (v.3), gire (v.5), gaudere (v.7). Numerosi i provenzalismi, latinismi ed espressioni meridionali.