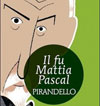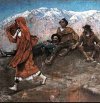FABULA E INTRECCIO
Il testo narrativo racconta una storia, cioè il susseguirsi di eventi in base a due differenti scelte narrative:
- Seguire la cronologia con cui si svolgono → FABULA
- seguire una successione arbitraria decisa dall’autore → INTRECCIO
FABULA (termine latino che significa racconto) = la storia si svolge secondo una concatenazione logico-causale degli eventi: accade il fatto A dal quale si origina un fatto B che determina l’accadere del fatto C, ecc.
INTRECCIO = l’ordine degli eventi non segue il concatenarsi cronologico, in questo caso la narrazione, capovolgendo l’ordine logico-causale, può iniziare dal fatto B per passare al fatto C e poi al fatto A.
L’intreccio è la rielaborazione da parte dell’autore della fabula e può coincidere con essa quando il narratore decide di seguire l’esatta cronologia dei fatti.
L’alterazione dell’ordine logico-cronologico della FABULA avviene attraverso due espedienti narrativi:
- ANALESSI o FLASHBACK (termine inglese che significa letteralmente lampo all’indietro): la rievocazione di vicende accadute in precedenza;
- PROLESSI: l’anticipazione di eventi che accadranno in futuro.
INIZIO, SVOLGIMENTO E FINALE
La narrazione prevede:
- Inizio;
- Svolgimento;
- Finale.
INIZIO
Inizio con cui il lettore “entra” nella storia. Si possono distinguere varie tipologie di inizio:
- inizio descrittivo, dettagliando l’ambientazione, i personaggi, il paesaggio, ecc.
Esempio: l’inizio de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni; - inizio narrativo, dando rilievo da subito alle azioni che fanno da motore alla storia.
Esempio: l’inizio de Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini; - inizio in media res, cioè partendo dal cuore della storia narrata, nel mezzo della situazione.
Esempio: l’inizio de La coscienza di Zeno di Italo Svevo.
SVOLGIMENTO
Svolgimento della trama della storia narrata.
FINALE
Finale con cui l’opera si commiata dal lettore. Tra i possibili finali vi possono essere:
- Finale con morale, conduce ad un insegnamento morale.
Esempio: il finale de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni; - Finale tragico, la vicenda si chiude in maniera drammatica.
Esempio: il finale de Il processo di Franz Kafka; - Finale aperto, la vicenda rimane in sospeso e permette al lettore di immaginare un proprio finale
Esempio: il finale de Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino; - Finale narrativo, la vicenda si conclude in maniera completa e con abbondanza di particolari.
Esempio: il finale de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; - Finale tronco, la vicenda si conclude improvvisamente.
Esempio: il finale de Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello; - Finale a sorpresa, la vicenda si conclude in maniera totalmente inaspettata rispetto a quanto si era immaginato dallo svolgersi dei fatti.
Esempio: il finale de Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia.
SEQUENZE NARRATIVE
Un racconto è composto da sequenze, ovvero unità narrative in cui si descrivono i vari episodi che compongono la storia narrata.
La sequenza si determina quando avviene una variazione di scena (per es.: la comparsa di un nuovo personaggio, un nuovo avvenimento, un mutamento spazio-temporale, ecc.) narra un episodio che può essere isolato dall’insieme della storia ed ha un inizio e una fine propri.
Vi possono essere:
- Macro-sequenze: sequenza molto ampia che comprende un insieme di sequenze e possono comprendere uno o più capitoli;
- Micro-sequenze: porzione narrativa ristretta isolabile all’interno di una sequenza.
Vi possono essere diversi tipi di sequenze:
- Sequenze narrative dette anche dinamiche: si basano sull’insieme dello svolgersi di eventi e situazioni oggetto della storia raccontata;
- Sequenze descrittive: si basano sul fornire informazioni e dettagli più o meno fedeli relativi ai soggetti, luoghi, sentimenti, ambienti, ecc. Le descrizioni possono essere:
- Oggettive: date in maniera impersonale ed esenti da commenti, si basa su un linguaggio scarno ed essenziale e ne deriva un’immagine precisa e fedele;
- Soggettive: date in base al filtro e al parere di colui che racconta (narratore o un personaggio), il linguaggio risulta ricco di particolari e commenti.
- Sequenze espositive: si basano sul fornire informazioni attraverso spiegazioni e criteri logici, spesso utilizzano come procedimenti espositivi l’enumerazione e il ragionamento;
- Sequenze dialogiche: si basano sul discorso diretto tra i personaggi e trasmettono l’impressione che la scena si svolga in tempo reale;
- Sequenze argomentative e persuasive: entrambe puntano a convincere il lettore ad assumere il punto di vista di chi narra ma differiscono perché:
- La sequenza argomentativa in cui chi narra (narratore o uno o più personaggi) vuole dimostrare una tesi a sostegno della quale espone degli argomenti che lo portano quindi ad una conclusione convincente e valida.
- La sequenza persuasiva non ha come scopo il dimostrare con la logica la veridicità di una tesi ma, semplicemente, il fine è di convincere l’interlocutore a fare una scelta piuttosto che un’altra, coinvolgendo la sfera emotiva e dei sentimenti.
- Sequenze riflessive o statiche in cui chi narra si sofferma sui propri giudizi, commenti e considerazioni.
- Sequenze lirico-espressive in cui chi narra esprime uno stato d’animo, una sensazione o ance un sentimento con una grande intensità emotiva, tale da rendere il linguaggio poetico e ricco di pathos.